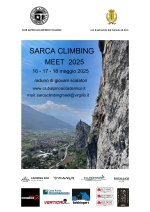News
E’ partita la missione di Survey Ambientale “Baltoro 2025” organizzata da CAAI e Mountain Wilderness
Come preservare l’ambiente dell’alta quota in Karakorum?
E’ partita la missione di Survey Ambientale “Baltoro 2025” organizzata da CAAI e Mountain Wilderness grazie al prezioso appoggio di Banca Sella Holding
di Mauro Penasa – Presidente Generale CAAI
Sono ormai passati 35 anni dalla spedizione Free K2, organizzata nel 1990 da Mountain Wilderness per liberare da rifiuti e corde fisse lo Sperone Abruzzi, la via “normale” per la vetta del K2. Già allora, ad appena 13 anni dalla seconda salita della montagna, le condizioni di degrado nelle quali versava il percorso sembravano intollerabili a qualunque appassionato di alpinismo. Ben tre tonnellate di materiale erano state rimosse dalla parete fino ad una quota di 7000 metri. Questo tipo di intervento, indispensabile per contenere l’accumulo di materiale abbandonato ai campi, serve comunque solo a tamponare una situazione per sua natura degenerativa: nonostante le numerose altre iniziative di pulizia che si sono succedute negli anni, le immagini raccolte al campo 2 nel 2022 indicavano una situazione alquanto sgradevole.
Il K2 è una montagna molto ripida, difficile e impegnativa, riservata ad alpinisti preparati, ma è pur sempre la seconda vetta del pianeta ed esteticamente è l’essenza della grande montagna, una piramide imponente e perfetta. La sua salita è quindi oltremodo ambita, e porta ad una frequentazione che diventa ogni anno più pressante. Simili testimonianze sulla situazione dei campi avanzati sui Gasherbrum sembrano confermare la cattiva abitudine che gli alpinisti hanno di abbandonare quanto non più indispensabile alla realizzazione del loro sogno creando gravi problemi ad una potenziale gestione della rimozione dei rifiuti ai campi alti.
 Il K2 visto salendo lungo la via normale del Broad Peak (foto Francois Cazzanelli)
Il K2 visto salendo lungo la via normale del Broad Peak (foto Francois Cazzanelli)
Nessuna attenzione in quota e gestione alquanto superficiale sui ghiacciai lungo il percorso del trekking: con questo quadro in mente Carlo Alberto Pinelli, Accademico del CAI e Presidente Onorario di Mountain Wilderness International, ha recentemente proposto all’Accademico di organizzare un convegno internazionale sulle azioni per ridurre l’impatto degli scalatori sul mondo dell’alta quota, dirigendo in particolare l’obiettivo sul K2, per la sua importanza alpinistica e per il rilievo iconografico che riveste nell’immaginario collettivo.
Indicativamente sulla montagna si muovono tra i 150 e i 250 alpinisti per una permanenza media di 45 giorni durante la stagione di scalata, tra metà giugno e metà agosto, ma lungo il trekking, tra escursionisti, portatori e personale di staff, il numero cresce fino a sfiorare le 10000 presenze, che circolano nell’area per un paio di settimane: si tratta di una pressione antropica difficile e problematica da gestire, considerando che si sta parlando di un ghiacciaio lungo più di 80 km e di campi base oltre i 5000 metri di quota. Secondo Pinelli “da tempo si assiste al progressivo degrado della qualità ecologica, estetica ed etica del K2 e delle alte montagne che lo contornano e che racchiudono il grandioso ghiacciaio del Baltoro. Le cause principali, dovute al periodico sovraffollamento dell’area facente parte del Central Karakorum National Park, si possono identificare nelle obiettive difficoltà dell’Amministrazione del Gilgit–Baltistan a gestire i rifiuti, nei controlli carenti e comunque complessi applicabili alle spedizioni alpinistiche, nella scarsa attenzione che spesso le grandi spedizioni commerciali prestano all’integrità dell’ambiente montano”.

Al ritorno della spedizione alpinistica biellese del 2024, Matteo Sella ha però testimoniato la presenza di squadre dedicate al recupero dei rifiuti sullo Sperone Abruzzi, e di come il trasporto verso valle di quanto raccolto sia sempre gestito a fine stagione dal personale del CKNP. Numerose testimonianze sembrano indicare che ci si sta muovendo nella direzione giusta, e che la situazione sia leggermente migliorata, anche ai campi in quota. Se poi si pensa alle montagne di rifiuti accumulate al Campo Base a fine stagione 2024, queste erano state debitamente rimosse per l’inizio della nuova stagione, come assicurato dai referenti sul posto.
Ancora Pinelli: “Un Convegno Internazionale per approfondire questo complesso problema dovrebbe individuare possibili e non utopistiche soluzioni sulle quali concentrarsi. Ma per evitare che il Convegno si riduca a una serie di affermazioni di principio, tanto generiche quanto inefficaci, abbiamo deciso di inviare Umberto Villotta, anche lui Accademico, in Pakistan per compiere una vera e propria inchiesta sul terreno, con l’assistenza del presidente della sezione Pakistana di Mountain Wilderness, Afzel Sherazee”.
 2022 – Sacchi di rifiuti al CB del K2 pronti per il trasporto a valle (foto CKNP) I nostri incaricati hanno obiettivo di raggiungere il campo base del K2, per monitorare durante la salita le condizioni dei diversi punti di sosta, incrociando durante il percorso sirdar, trekkers, portatori e ascoltando i loro suggerimenti, in modo da mettere a confronto i diversi punti di vista – quello delle agenzie turistiche, dei portatori Baltì, degli operatori del CKNP, in un momento in cui la stagione sta terminando ed oltre il quale non sono prevedibili ulteriori interventi. Ciò consentirà di fotografare una situazione che verosimilmente è quella in effetti rilevabile a regime e sulla quale impostare ogni futura discussione.
2022 – Sacchi di rifiuti al CB del K2 pronti per il trasporto a valle (foto CKNP) I nostri incaricati hanno obiettivo di raggiungere il campo base del K2, per monitorare durante la salita le condizioni dei diversi punti di sosta, incrociando durante il percorso sirdar, trekkers, portatori e ascoltando i loro suggerimenti, in modo da mettere a confronto i diversi punti di vista – quello delle agenzie turistiche, dei portatori Baltì, degli operatori del CKNP, in un momento in cui la stagione sta terminando ed oltre il quale non sono prevedibili ulteriori interventi. Ciò consentirà di fotografare una situazione che verosimilmente è quella in effetti rilevabile a regime e sulla quale impostare ogni futura discussione.
Sottolinea Villotta: “Credo che ormai sia ben chiaro a chi vive di turismo di alta quota, si tratti di alpinismo o di semplice escursionismo, che lo sfruttamento di un bene tanto prezioso richiede attenzione e sensibilità. Finora l’inquinamento degli ambienti glaciali non ha fermato gli appassionati lungo uno dei trekking più entusiasmanti che l’alta montagna possa offrire. Negli ultimi anni è stato messo molto impegno per gestire al meglio la situazione, e parallelamente è cresciuta la consapevolezza della fragilità di queste montagne grandiose. Oggi è evidente che la loro protezione passa attraverso un’azione concertata di prevenzione presso gli utenti, di gestione ambientale della loro visita, e di ripristino progressivo delle zone alterate. Noi cercheremo di riuscire a raccogliere dati ed idee, per poterne parlare con cognizione di causa”.
 Trasporto di rifiuti con i muli dall’area di raccolta al CB del K2 – 2022 (foto Yasir Abbas/CKNP)
Trasporto di rifiuti con i muli dall’area di raccolta al CB del K2 – 2022 (foto Yasir Abbas/CKNP)

 Umberto e Afzel al loro arrivo a Skardu (foto Umberto Villotta)La missione, partita in questi giorni, è stata ricevuta dall’ambasciatrice italiana in Pakistan Marilina Armellin, ed è in seguito volata a Skardu da dove inizierà il viaggio sul Baltoro. Al termine, Sherazee e Villotta saranno impegnati in una nutrita serie di incontri per approfondire l’argomento con i dirigenti governativi del Gilgit-Baltistan e con i rappresentanti del CKNP. In base alle informazioni raccolte si valuterà l’opportunità di contattare i ministeri federali interessati al Turismo e alla Tutela Ambientale, al fine di ottenere il loro futuro supporto.
Umberto e Afzel al loro arrivo a Skardu (foto Umberto Villotta)La missione, partita in questi giorni, è stata ricevuta dall’ambasciatrice italiana in Pakistan Marilina Armellin, ed è in seguito volata a Skardu da dove inizierà il viaggio sul Baltoro. Al termine, Sherazee e Villotta saranno impegnati in una nutrita serie di incontri per approfondire l’argomento con i dirigenti governativi del Gilgit-Baltistan e con i rappresentanti del CKNP. In base alle informazioni raccolte si valuterà l’opportunità di contattare i ministeri federali interessati al Turismo e alla Tutela Ambientale, al fine di ottenere il loro futuro supporto.
Al termine del progetto ci si augura di avere a disposizione un report finale completo ed aggiornato sulla situazione del Baltoro da cui partire per discuterne le diverse problematiche ed arrivare alla proposta di soluzioni percorribili.
Il problema dell’impatto umano prende però sfumature diverse man mano che ci si alza di quota. La gestione dei rifiuti lungo il trekking ed ai campi alti presenta problematiche differenti e richiede specializzazioni diverse. Mentre il recupero sul ghiacciaio viene gestito direttamente dai dipendenti del CKNP e si avvale di portatori e bestie da soma che altrimenti scenderebbero sostanzialmente scarichi, lungo lo Sperone Abruzzi è necessario ingaggiare portatori d’alta quota specializzati, che lavorano in condizioni difficili e spesso pericolose. L’innalzamento delle temperature, evidente nelle ultime annate, tende da un lato a far emergere quanto sepolto da tempo, ma soprattutto espone il terreno a scariche di roccia che mettono a repentaglio la vita di chi si muove sulla montagna. E’ evidente quindi la necessità di ridurre la produzione di rifiuti per limitare le azioni di recupero.
L’Accademico Gian Luca Cavalli è appena tornato dal K2: “Il Campo Base, che a fine stagione 2024 era pieno di cumuli di immondizia, al mio arrivo a giugno era sorprendentemente pulito. E i campi sullo sperone non certo peggiori dell’anno precedente. Qualcosa si sta facendo, ma gestire il problema dall’esterno è diseducativo. E’ la sensibilità dell’alpinista che dovrebbe arrivare a mantenere la pulizia. Se durante le rotazioni ai campi alti indispensabili per acclimatarsi quanti scendono si preoccupassero di recuperare qualche rifiuto, a fine stagione i problemi sarebbero molto meno evidenti. Sarebbe opportuno formare gli ufficiali di collegamento sul tema specifico, in modo che siano loro a sensibilizzare gli alpinisti”.
Gli alpinisti si sentono in naturale diritto di ergersi a paladini della montagna, l’amato terreno dei loro sogni, e rimuovono con fastidio l’idea di essere proprio loro una grave causa di degrado. Nel nome di leggerezza e sicurezza personale sui terreni rischiosi, gli alpinisti sono i primi ad approfittarne per abbandonare il materiale quando diventa un peso inutile per la salita. Non c’è bisogno di andare sugli 8000, lo vediamo nei nostri bivacchi, quelli dove solo gli scalatori possono mettere piede: tutto ciò che non serve viene abbandonato, trasformando in breve un rifugio di importanza fondamentale in quello che può essere percepito come un immondezzaio.
Più persone circolano, maggiori i problemi. A meno di un cambio di marcia sull’organizzazione, che è un passaggio inevitabile.


Negli ultimi 5 anni la cima è stata calcata da almeno 400 alpinisti, lo stesso numero di salite realizzate nei precedenti 65, a testimonianza che le spedizioni commerciali funzionano anche su una montagna davvero tecnica e per un’utenza più selezionata. Una migliore attrezzatura della via di salita si è tradotta in un sensibile aumento della percentuale di successo, con riduzione notevole degli incidenti. Verosimilmente questo porterà in futuro ad una ancor maggiore frequentazione con inevitabile incremento dei materiali che circolano sullo “Sperone Abruzzi”, e ciò richiederà una gestione oculata, anche se non si arriverà mai ad una situazione simile a quella proposta dalla salita all’Everest dal versante nepalese.
Il CAAI non è il depositario unico dell’etica dell’alpinismo. Per quanto le spedizioni commerciali rimandino ad un’idea di sfruttamento della montagna agli antipodi della nostra concezione di alpinismo, è evidente che affrontare il K2 con corde fisse e ossigeno supplementare non elimina del tutto il valore di questa salita, che rimane una delle più difficili e che, in qualunque modo si sia completata, richiede dunque rispetto. Pur rilevando che è l’avventura a garantire i maggiori compensi all’alpinista, penso proprio che senza fisse e ossigeno la salita del K2 sarebbe appannaggio di pochi, e soprattutto che ben più persone finirebbero col perdere la vita sulla montagna. Peraltro, anche con attrezzatura perfetta, è indispensabile porre ogni attenzione a preparare bene gli alpinisti per la salita al K2: altrimenti, in caso di problemi, la cosa potrebbe facilmente tradursi in un disastro.
 Collo di bottiglia (2023, foto Tashi Lakpa Sherpa)L’alternativa di lasciare le grandi salite ai fuoriclasse non è in linea con la storia dell’alpinismo, che si nutre dei sogni di tanti. Così, la rilevanza socioculturale delle imprese alpinistiche vale inizialmente più di quella economica ma ben presto tende ad esserne sopraffatta. L’occupazione dei territori prima ed il loro sfruttamento poi sono infatti processi tipici della nostra civiltà. Vietare la frequentazione è una possibile soluzione per ridurre l’impatto umano, ma è molto impopolare e decisamente improponibile per i giganti della Terra: si tratta di un’ultima opzione che non verrà percorsa se non per emergenze apocalittiche.
Collo di bottiglia (2023, foto Tashi Lakpa Sherpa)L’alternativa di lasciare le grandi salite ai fuoriclasse non è in linea con la storia dell’alpinismo, che si nutre dei sogni di tanti. Così, la rilevanza socioculturale delle imprese alpinistiche vale inizialmente più di quella economica ma ben presto tende ad esserne sopraffatta. L’occupazione dei territori prima ed il loro sfruttamento poi sono infatti processi tipici della nostra civiltà. Vietare la frequentazione è una possibile soluzione per ridurre l’impatto umano, ma è molto impopolare e decisamente improponibile per i giganti della Terra: si tratta di un’ultima opzione che non verrà percorsa se non per emergenze apocalittiche.
E’ quindi necessario lavorare sugli alpinisti e parallelamente sulle agenzie: chi si occupa di portare in cima un nutrito gruppo di clienti si deve prendere in carico gli aspetti ambientali correlati, controllando il flusso di materiali in salita e in discesa, ed evitando di rovinare un bene delicato che è la base stessa della nostra passione di alpinisti…
Ogni appassionato di alpinismo non può esimersi dal compito di limitare il proprio impatto ambientale, a livello personale ma anche a livello istituzionale. La nostra storia ci chiede uno sforzo in questa direzione. Mountain Wilderness e CAAI sono da sempre impegnati nella difesa dell’etica in montagna, anche se spesso su fronti diversi. L’inquinamento delle terre alte è però un aspetto trasversale che accomuna l’azione delle due istituzioni.
Ma ben poco avremmo potuto fare su questo progetto senza l’aiuto di Banca Sella Holding, da sempre sensibile ai temi dell’alpinismo, della sua storia e interessata alle problematiche dell’alta quota, tanto più al K2. Le più belle foto di Himalaya e Karakorum ci arrivano infatti da Vittorio Sella, che visitò la montagna insieme al Duca degli Abruzzi nel 1909. Pietro, pronipote di Vittorio, nel 2024 ha ripercorso il Baltoro cercando, non senza difficoltà, di ripetere gli scatti del prozio a 115 anni di distanza, ottenendo un risultato sorprendentemente accurato. Il ghiacciaio principale non ha evidenziato variazioni importanti, al contrario dei suoi tributari laterali che si dimostrano ben colpiti dal riscaldamento globale. Davanti all’evidenza di queste problematiche Banca Sella Holding ha accettato la richiesta di appoggio di CAAI e MW, dimostrando un sicuro l’interesse per un eventuale futuro Convegno Internazionale sul tema.


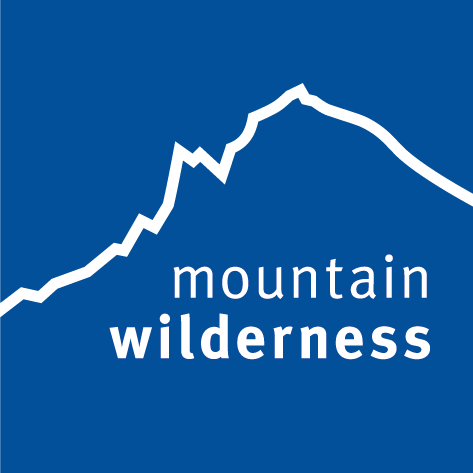
di Gianni Ghiglione-Alpinista
Revisione a cura di Fausto Camera
Andare oltre…cosa vorrà dire poi….
In questo articolo vorrei esporre le mie osservazioni e le mie convinzioni riguardo all'apertura di nuovi itinerari, alla ricerca di emozioni ancora inesplorate.
Mi rendo conto ora che questo argomento mi ha sempre appassionato anche se nei primi tempi era una pura e semplice ambizione da raggiungere.
Perchè? È necessaria una premessa. Capita di chiedersi quante siano le scelte che vengono inconsapevolmente prese nell’arco di una
giornata per compiere un semplice gesto o esprimere un pensiero.
Situazioni molto meno importanti di quando, invece, interviene il ragionamento e si possono prendere decisioni che influenzano il futuro e la vita.
Attorno ai vent’anni, appunto, e durante il mio corso di studi mi sono chiesto spesso ciò che volevo fare da grande.
Se la scelta fosse tra “lavorare per vivere” o “vivere per lavorare”, senza incertezze scartai la carrieristica opportunità e mi votai alla prima alternativa che mi concedeva del tempo libero da dedicare alla mia passione per la montagna e all’arrampicata su roccia.
 L’alternativa si tramutava così in “vivere per arrampicare” e le mie prime esperienze di alpinista rocciatore avvennero sulle fantastiche pareti che si trovano nelle vicinanze di Finale Ligure: affascinanti e immense nelle loro suggestioni.
L’alternativa si tramutava così in “vivere per arrampicare” e le mie prime esperienze di alpinista rocciatore avvennero sulle fantastiche pareti che si trovano nelle vicinanze di Finale Ligure: affascinanti e immense nelle loro suggestioni.
Lì ho avuto modo di conoscere due grandi alpinisti: Gianni Calcagno e Giancarlo Grassi, quasi miei coetanei, ai quali ho chiesto di unirmi a loro come compagno di cordata. Essi accettarono con piacere, non li dimenticherò mai, e con loro effettuai numerose salite, anche nuove. E’ grazie a loro che mi sono avvicinato al desiderio forte di aprire nuovi itinerari. Desiderio che si è ampliato nel corso del tempo e che mi ha accompagnato poi durante tutto il mio successivo percorso alpinistico.
Una componente che principalmente mi ha attratto è che la scalata genera di per sé una qualità di emozioni veramente profonde, soprattutto nella ricerca di vie nuove.
Questa concentrazione, indotta dalla parete, risulta sicuramente superiore a quella generata da qualsiasi lavoro, anche se molto impegnativo.
Come sappiamo durante un lavoro, anche se si è molto concentrati, il mondo attorno a noi viene semplicemente ignorato ma non cessa mai di essere presente dentro di noi.
Nell’alpinismo, invece, la concentrazione conduce ad una stimolazione psicologica tale che il mondo viene escluso ed escludere è un livello più elevato che ignorare.
Poiché considero l’apertura di un nuovo itinerario come un’opera d’arte (non in tutti i casi, in alcune di esse c’è imperfezione, non c’è arte) e quindi di opera artistica, credo che sia molto importante nell’ambito dell’alpinismo, ma anche in altri ambiti, avere la consapevolezza che non si progredisce facendo meglio cose già fatte ma creando cose che non esistono.
L’opera d’arte prodotta lascia quindi una memoria storica, è proprio per queste ragioni che non dovrebbe essere modificata dai ripetitori.
La mia decennale esperienza nell’alpinismo è sempre stata fortemente orientata alle attività di ricerca ed esplorazione
Nell’alpinismo esiste il libero arbitrio, questo non significa che ognuno può far indiscriminatamente quello che vuole, ma che chi apre deve identificarsi nell’etica della zona in cui si vuole aprire la via. Considerando che l’essenza degli esseri umani è la curiosità, l’alpinista osserva attentamente le pareti che ha di fronte, valuta e traccia mentalmente a distanza l’itinerario che vuole percorrere.
E’ assolutamente necessario rispettare l’ambiente e quindi è doveroso, durante l’individuazione dell’avvicinamento, non fornire agli eventuali ripetitori tracce elettroniche di tipo GPS ma semplicemente descrizioni.

Quanto sarebbe stato scontato il viaggio di Ulisse se guidato dai satelliti e non dall’umore volubile degli dei.
Spesso gran parte della civiltà civile afferma che l’alpinismo è un’attività inutile, non produce benefici, è un’attività che va evitata in quanto pericolosa.
Tutto questo perché molte persone non sanno vedere ciò che esiste oltre una linea di demarcazione rappresentata dal lavoro.
Non si riesce a comprendere ciò che c’è di utile in progetti ritenuti inutili. Faccio un esempio. Le tre cime di Lavaredo viste dal rifugio Locatelli sono uno spettacolo veramente notevole ma rappresentano una conoscenza delle pareti piuttosto superficiale.
Solo l’alpinista, arrampicando su tali pareti, individua con precisione assoluta la loro vera natura metro dopo metro.
E’ questa una delle componenti utili per comprendere che l’esplorazione minuziosa e attenta della natura in ogni sua forma, nella sua morfologia, sia estremamente importante.
L’alpinismo, quello eticamente corretto e non commerciale, vede le scalate sotto un altro profilo, si occupa integralmente di cose che né si vendono né si comprano.
Sono esenti dal profitto. Le vie alpinistiche sono creazioni pure e incorrotte, concepite non per soldi ma per l’arte in se stessa; rappresentano un dono per l’essere umano.
Quando mi avvicino ad una parete sconosciuta e questo mi è capitato in molte occasioni, in particolare nelle magnifiche pareti della Corsica dove ho aperto delle vie nel gruppo di Popolasca, Bavella e Restonica, inizio soprattutto a stabilire un dialogo intimo con la parete.
La parete mi parla, io l’ascolto e quindi mi obbliga a scegliere il materiale che dovrò usare.
Se la parete mi suggerisce di usare chiodi tradizionali, o friends, perché presenta soluzioni di continuità come crepe o buchi penetrabili con normali chiodi classici, userò questi mezzi, ma se la parete è totalmente compatta come in Corsica, succede quasi sempre, sarò quindi costretto a profanare la roccia (se voglio aprire la via) con un trapano e inserire spit o fix.
Così, nel gruppo di Popolasca, ma anche al Monte Butara ad esempio o al Monte U Finellu dove ho operato, mi sono servito di spit sia durante l’arrampicata che nelle soste, cercando di rendere la via sicura agli eventuali ripetitori ma nel contempo senza abusare nella chiodatura mantenendo ciò che ho sempre ritenuto una giusta distanza tra i rinvii.
 Una cosa importante è che difficilmente io parlo di mie vie aperte.
Una cosa importante è che difficilmente io parlo di mie vie aperte.
Ritengo che le vie aperte siano un fatto internazionale che non implica un attaccamento alle vie, come dice il Buddismo in parte della sua filosofia.
Ciò implica che, a mio avviso, l'alpinismo non ha confini politici o statali e che il mondo dovrebbe
avere un’unica bandiera, il mondo è di tutti indistintamente, puntando all'uniformità.
Così come considero tutte le zone del mondo una terra meravigliosa che appartiene a tutti, è mia convinzione che tutte le vie aperte debbano rimanere così come sono state aperte al fine di trasmettere ai ripetitori e alle future generazioni la memoria storica di come si sono svolti i fatti e offrire ai successivi ripetitori l’opportunità di entrare nell’interiorità dell’apritore rivivendo le sue stesse emozioni.
Se la via venisse modificata non si proverebbero più. Quale barbarie sarebbe modificare le vie ad esempio di Bonatti o Desmaison, non lasciandole come loro le hanno aperte.. Sarebbe un enorme abominio.
Modificare una via tracciata in precedenza è un atto cinico e prevaricatore di chi è caratterizzato da un forte istinto predatorio e ha l’obiettivo di nascondere la propria inadeguatezza ad accettare il rischio insito nella via originaria. Un comportamento del genere equivale a un reato.
Questo procedimento equivale a un furto sentimentale, è annullare le emozioni provate dal primo apritore, è tentare di far cantare alle vie rubate il canto del cigno.
Si perde la consapevolezza di ciò che è stato vissuto nel passato. E’ falsificare gli eventi storici.
Durante le scalate, soprattutto nella fase iniziale, la paura esiste, è amica, ma è un’amica pericolosa. Solo interpretandola diventa alleata e abbatte la soglia del rischio.
Queste mie ultime affermazioni richiedono però un approfondimento. Nella parte più profonda del nostro inconscio agiscono due forze contrapposte.
La prima è la forza del cambiamento che ha come obiettivo di spingerci verso l’arrampicata ed ha caratteristiche rafforzative; la seconda è la resistenza al cambiamento e che quindi si oppone a questo: è una forza sabotante. Ambedue queste forze comunque hanno come obiettivo il nostro benessere.
Come alpinisti ci chiediamo per quale ragione questi meccanismi sono così predominanti nella profondità della nostra mente. La spiegazione è antropologica ed evolutiva. L’evoluzione di homo sapiens come specie non ha come primo obiettivo il benessere interiore, bensì la sopravvivenza.
Per prima cosa, perciò, il cervello primitivo ha prodotto meccanismi di difesa. Senso di pericolo, paura, allerta, aggressività sono stati evolutivamente gli istinti primordiali che ci hanno permesso la sopravvivenza. A livello limbico siamo ancora, evolutivamente, impostati sulla sopravvivenza e sul dolore. La nostra mente coglie le sensazioni di dubbio, paura, stress, ansia e automaticamente le interpreta come un segnale di pericolo, cercando di compiere tutte le azioni necessarie per tornare allo stato iniziale. Passiamo da una modalità di crescita a una modalità protettiva, causata dalla paura, dedicando tutta la nostra energia alla nostra protezione. Possiamo dimenticare il passato, ma è il passato che non si dimentica di noi. Il nostro cervello agisce per via riflessa, smettendo di pensare e iniziando ad agire, guidato unicamente dall’istinto di sopravvivenza.
Di fronte al pericolo, la fisiologia del nostro corpo ci prepara ad affrontare la situazione con queste due uniche soluzioni possibili: fuggi o lotta.
L'amigdala agisce direttamente sull'asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA), una parte del sistema limbico che attiva questo meccanismo lotta/fuggi e ci prepara all'azione.
Il nostro organismo viene sottoposto all’azione di particolari ormoni che ci aiutano a concentrarci per pensare velocemente a una soluzione. I principali sono l'adrenalina e l’idrocortisone, rilasciati nel torrente sanguigno in modo da aumentare il tono muscolare, la frequenza cardiaca, gli atti respiratori e l’acuità visiva (maggior percezione della realtà circostante), aiutano a concentrarci per pianificare e pensare velocemente a un modo per risolvere la difficile sezione rocciosa che ci sovrasta.
Le insidie che si incontrano durante le scalate sono diverse da quelle che incontrava l’uomo primitivo, ma il nostro cervello, le codifica ancora in quel modo.
Infatti scritto nella parte più antica del nostro cervello c'è lo stesso istinto di sopravvivenza e di pericolo dei nostri antenati. Durante la scalata la cosa più istintiva è la paura, la diffidenza, la paura della morte.
La paura è quindi utile; utile per evitare rischi e consentire di arricchire con ulteriori appassionanti momenti il fascino per la montagna.
E’ in pieno svolgimento la spedizione in Mozambico che vede impegnati quattro Accademici del Gruppo Orientale: Manrico Dell’Agnola, Maurizio Giordani, Mirco Grasso e Samuele Mazzolini, insieme a Nancy Paoletto e Antonella Giacomini e con l’appoggio e consulenza in loco di Anna Mazzolini (Urban Governance Expert presso UN-HABITAT).
 Atterrato a Maputo, il team, dopo gli adempimenti burocratici e la visita all’Ambasciata Italiana, ha raggiunto la base dell’inesplorata montagna, denominata Phandambiri, dove è stato allestito il Campo Base. Si tratta di un picco aguzzo di granito che si slancia isolato con pareti di oltre 800 metri, caratteristico perché si trova in mezzo alla piatta savana, nel remoto distretto di Macossa.
Atterrato a Maputo, il team, dopo gli adempimenti burocratici e la visita all’Ambasciata Italiana, ha raggiunto la base dell’inesplorata montagna, denominata Phandambiri, dove è stato allestito il Campo Base. Si tratta di un picco aguzzo di granito che si slancia isolato con pareti di oltre 800 metri, caratteristico perché si trova in mezzo alla piatta savana, nel remoto distretto di Macossa.
La montagna, che non presenta versanti deboli, sembrerebbe non essere mai stata salita.
I membri della spedizione, accampati in prossimità delle pareti, dopo una completa ricognizione della zona con il periplo della montagna, hanno individuato due linee di salita e si sono mesi all’opera, scalando già parecchi tiri su un granito compattissimo e ricco di straordinari “funghi”.
A breve avremo resoconti più dettagliati di queste scalate e dell’ambiente molto particolare del Phandambiri.
Aggiornamenti anche su Verso il Phandambiri



Le numerosissime foto di scalata e di momenti insieme inviateci dai partecipanti testimoniano l’entusiasmo che l’evento ha saputo creare e crediamo che il modo migliore per ricordare questo meeting sia proprio pubblicare una parte di questi scatti assieme al video ufficiale della manifestazione.
Grazie a tutti per il vostro impegno e per la bella atmosfera che si è creata.
 Ph Jonata Rivaroli
Ph Jonata Rivaroli
 Ph Lucia Lorenzi
Ph Lucia Lorenzi
 Ph Lucia Lorenzi
Ph Lucia Lorenzi
 Ph Rebecca Lugaro
Ph Rebecca Lugaro
I
 Ph Marta Andreose
Ph Marta Andreose
 La Parete Est del Dain delle Sarche - ph Jonata Rivaroli
La Parete Est del Dain delle Sarche - ph Jonata Rivaroli
 Ph Gabriele Bozzoli
Ph Gabriele Bozzoli
 Ph Gianpaolo Battoglia
Ph Gianpaolo Battoglia
 Ph Jonata Rivaroli
Ph Jonata Rivaroli



 Lo staff - Ph Arch A. Rampini
Lo staff - Ph Arch A. Rampini

 Lo Staff - Ph A. Rampini
Lo Staff - Ph A. Rampini


Di seguito solo alcune note per sintetizzare l’evento. Maggiori dettagli in questo articolo pubblicato da Planet Mountain.
 I ragazzi dell'EAGLE TEAM
I ragazzi dell'EAGLE TEAM
 I ragazzi dell'EAGLE TEAM
I ragazzi dell'EAGLE TEAM
 Matteo della Bordella, leader del gruppo EAGLE TEAM
Matteo della Bordella, leader del gruppo EAGLE TEAM
 Maurizio Giordani presenta "il richiamo dell'ignoto"
Maurizio Giordani presenta "il richiamo dell'ignoto"
 Giampaolo Calzà presenta "Arrampicarsi nella Valle del Sarca"
Giampaolo Calzà presenta "Arrampicarsi nella Valle del Sarca"


 Pareti del Sarca - Cima alle Coste - Ph A. Rampini
Pareti del Sarca - Cima alle Coste - Ph A. Rampini
 Ph Gabriele Bozzoli
Ph Gabriele Bozzoli
 Ph Gianpaolo Battoglia
Ph Gianpaolo Battoglia
 Ph Jonata Rivaroli
Ph Jonata Rivaroli
 Ph Gianpaolo Battoglia
Ph Gianpaolo Battoglia
 Ph Gianpaolo Battoglia
Ph Gianpaolo Battoglia
 Ph Serafino Ripamonti
Ph Serafino Ripamonti


 Ph A. Rampini
Ph A. Rampini
 Ph A. Rampini
Ph A. Rampini
 Ph A. Rampini
Ph A. Rampini
 Ph Serafino Ripamonti
Ph Serafino Ripamonti






Il SARCA CLIMBING MEET Edizione 2025, organizzato dal Gruppo Orientale del Club Alpino Accademico Italiano, è stato indubbiamente un bel successo. E’ stato premiato l’impegno degli organizzatori ed è risultata vincente l’idea di creare un’occasione di stimolo, discreta ma molto accattivante, per far interagire tanti ragazzi di età compresa tra i 18 e i 30 anni provenienti da tutta Italia e in buona parte già operanti all’interno di Scuole di Alpinismo e Arrampicata.
Quasi cento tra giovani alpinisti e Accademici hanno scalato sulle pareti della Valle del Sarca il 16,17 e 18 maggio e maturato assieme una esperienza tecnica, umana e culturale di sicuro interesse. Molto seguite le due serate “culturali” a Palazzo Panni: Giampaolo Calzà ha illustrato le vie di avventura meno note sulle grandi pareti della Valle e Maurizio Giordani ha portato la propria esperienza di alpinista poliedrico continuamente affascinato dal nuovo, “il richiamo dell’ignoto”, uno stimolo potente per il giovane pubblico che assiepava la sala.
Guidati da Matteo della Bordella erano presenti anche i ragazzi dell’Eagle Team, che hanno festeggiato i successi delle recenti spedizioni in Patagonia e Oman a coronamento della prima edizione di questo importante momento formativo organizzato da CAI e CAAI.
Numerose le autorità e personalità CAAI presenti all’iniziativa, tra le quali il Presidente Generale Mauro Penasa, i Presidenti dei Gruppi Fulvio Scotto, Claudio Inselvini e Francesco Leardi oltre a diversi membri del Consiglio Generale.
Un dovuto ringraziamento allo staff organizzativo coordinato da Guido Casarotto e Alberto Rampini, al Comune di Arco per il patrocinio e al Camping Zoo di Arco per l’ospitalità di alto livello.
Un ringraziamento, infine, va al presidente della Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo del CAI Mauro Loss, per la fattiva collaborazione, al Comune di Arco di Trento, patrocinatore dell’iniziativa, e ai partner che hanno dato il loro sostegno al progetto: Cassa Rurale Alto Garda Rovereto, Rock Experience, Camp, Idea Montagna Editoria Alpinismo, Camping Zoo, Rock&Ice Cortina, Vertical Sport, Gobbi Sport, Red Point e Climbing Village Arco. Grazie infine a Marta Andreose che ha curato la regia del film.


 Ph Gabriele Bozzoli
Ph Gabriele Bozzoli
 Ph Gabriele Bozzoli
Ph Gabriele Bozzoli
 Ph Jonata Rivaroli
Ph Jonata Rivaroli
 Ph Jonata Rivaroli
Ph Jonata Rivaroli
 Ph Lucia Lorenzi
Ph Lucia Lorenzi
 Ph Serafino Ripamonti
Ph Serafino Ripamonti
 Ph Rebecca Lugaro
Ph Rebecca Lugaro
 Ph Mikhail Todoverto
Ph Mikhail Todoverto
Relazioni di Franco Sartori
Gruppo di Brenta Cima Borcola (2392 m)
Nelle Dolomiti di Brenta si trovano ancora degli angoli seminascosti dove regna lo stambecco amante di questi luoghi solitari disturbato solo sporadicamente da persone del posto che fanno trekking. A livello alpinistico ci sono delle intere pareti ancora vergini dove è possibile fare dell’alpinismo d’avventura in posti magici di rara bellezza e lontani da qualsiasi rumore. L’ideale per trascorrere delle giornate immersi nella natura. Uno fra questi è Alpe la Campa un vero e proprio scrigno di tesori naturalistici e pareti rocciose, situato esattamente nel Sottogruppo della Campa.
Cima Borcola, 2392 metri di quota, è la Cima più ardua del luogo, imponente per la sua forma a piramide dominata da una grande croce metallica visibile già dal fondo valle.
Dal versante rivolto ad Est, percorrendo il sentiero che da Malga Sporminore porta a Malga Campa, abbandonando il sentiero in vista della Cima e della grande croce si può salire per pendii erbosi fino in vetta per godere di un panorama mozzafiato. Sul versante Ovest, roccioso e in prevalenza più verticale, si trova uno spigolo salito molto sporadicamente da cordate locali (qualche vecchio chiodo testimonia la salita). Alpinisticamente il versante più interessante è rivolto a Nord, con una parete alta circa 200/250 metri quasi completamente verticale e con roccia in prevalenza buona dove si possono individuare delle linee di salita di una certa logica.
La “Diretta Sartori” è una via che sale a goccia d’acqua in vetta per una linea logica dal sapore esplorativo. Adatta a cordate amanti della montagna in cerca di luoghi da esplorare, è di difficoltà contenuta tranne qualche breve tratto attrezzato e si presta a cordate meno allenate in grado però di posizionare le protezioni veloci (con una serie completa di friend si riesce a proteggersi molto adeguatamente).
Gruppo di Brenta
Cima Borcola metri 2392
“ Diretta Sartori"
scarica la relazione in formato pdf
Apritori: Sartori Franco in solitaria Agosto 2024
Difficolta: IV/V/VI Sviluppo: metri 230 Esposizione: nord
Materiale: N.D.A. una serie completa di friend fino al 4 BD
Avvicinamento: Dal Paese di Cunevo (Val di Non) salire verso Malga d’Arza fino a raggiungere il parcheggio nei pressi della Malga. Dalla Malga seguire le indicazioni per Malga Loverdina e in seguito per Malga Campo Denno (ore 1.30/2 circa).
NB esiste la possibilità di dormire al bivacco della Malga (corrente elettrica, letti con coperte, acqua potabile e cucina con stufa e pentolame).
Attacco: In vista della parete si prosegue per il sentiero con indicazioni Malga Sporminore ed in breve si raggiunge il ghiaione sottostante Cima Borcola. Abbandonare il sentiero per salire senza via obbligata per i ghiaioni puntando alla grande cengia che taglia tutta la parete. Raggiungere un grosso diedro nero e molto evidente, oltrepassarlo in salita per qualche metro fin sotto la verticale di una serie di diedri fessurati. Clessidra alla base evidenziata con cordone.(Tempi 30 minuti circa)
Discesa:
1 = Dalla cima seguire un piccolo sentiero verso Sud per un breve tratto fino a raggiungere un intaglio sulla destra e scendere con attenzione per il ripido canale che porta sotto la parete ed in seguito al sentiero per la Malga Campo
2 = Soluzione più lunga ma consigliata. Dalla cima raggiungere lo stesso intaglio e scendere sulla sinistra senza via obbligata più agevolmente per il ripido pendio erboso per raggiungere il sentiero che da Malga Sporminore porta a Malga Campo
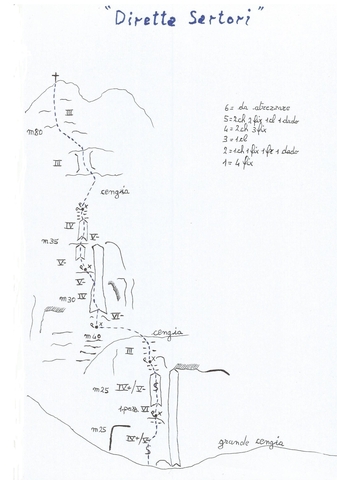

Gruppo Roen - Cime di Vigo
Cima Cornella
“Via Sensazioni di Primavera”
scarica la relazione in formato pdf
Apritori: Sartori Franco in solitaria Gennaio – Febbraio 2024
Difficoltà: VI/VII/VIII+
Sviluppo: metri 110 Esposizione: Sud-Ovest
Materiale: N.D.A. 15 rinvii, una serie di friend medio piccoli
Avvicinamento: Da Mezzolombardo proseguire in direzione Val di Non per 2 km circa. Subito prima dell’imbocco della galleria parcheggio sulla sinistra. Proseguire a piedi per una vecchia strada asfaltata visibile dal parcheggio e sbarrata da una stanga. Da lì salire per il sentiero segnalato 516B che sale in direzione M. Boldrina. Dopo pochi minuti, giunti ad un secondo cartello, proseguire sulla sinistra e salire per il sentiero a zig zag raggiungendo il punto dove la parete resta ben visibile sopra al sentiero sulla destra (30 minuti circa).
Attacco: Abbandonare il sentiero e salire sulla destra seguendo gli ometti giungendo ad un bel ripiano puntando ad una pianta. Ben visibili i fix sulla sua sinistra e a destra di uno strapiombo.
Discesa: Raggiunta l’ultima sosta salire per roccette verso sinistra ed in breve raggiungere, sempre sulla sinistra, il sentiero 516B che si segue in discesa fino al parcheggio (40 minuti circa).
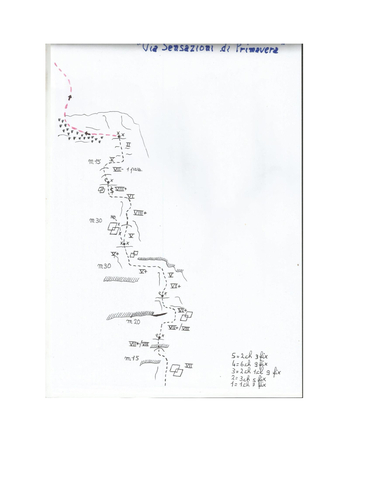
Monte Fausior
“Via Oro e Metallo”
scarica la relazione in formato pdf
Apritori: Sartori Franco primavera 2024
Difficoltà: VI/VII/VIII Sviluppo: metri 450 Esposizione: Nord – Est
Materiale: N.D.A., 15 rinvii, necessarie 2 corde per la discesa. Roccia ottima
Avvicinamento: Da Mezzolombardo proseguire in direzione Fai della Paganella e al quinto tornante parcheggiare a sinistra in un’area picnic. Proseguire per 50 metri circa fino ad un guardrail: di fronte sale nel bosco una traccia di sentiero segnata da ometti e bolli rossi che porta all’ attacco (40 minuti circa).
Attacco: Si sale per un evidente diedro con un piccolo avancorpo alla base. Visibile un chiodo a tre metri circa di altezza. Bollo rosso alla partenza.
Discesa: 11 corde doppie seguendo le indicazioni dello schizzo. Soste attrezzate.

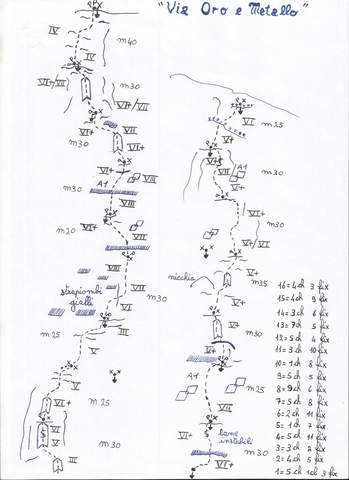
Abbiamo già proposto un ampio resoconto della spedizione organizzata in Oman dal CAI EAGLE TEAM tra febbraio e marzo 2025. Questa avventura, come ricordava Marco Ghisio, coordinatore dell'evento, "ha rappresentato la naturale conclusione di un progetto incentrato sulle giovani promesse del mondo dell’alpinismo e arrampicata. Giovani che finalmente hanno potuto godere dei frutti delle varie settimane di formazione e mettere in pratica quanto appreso, in un luogo opportunamente scelto non solo per collaborare allo sviluppo turistico e sportivo del territorio omanita ma anche per la quantità e qualità di pareti rocciose a disposizione ancora da esplorare. È grazie a questi due aspetti fondamentali, uniti alla voglia di fare gruppo che i ragazzi hanno messo in atto, che la spedizione può vantare gli ottimi risultati raggiunti".
Dal punto di vista pratico la spedizione lascia sul terreno ben 12 vie nuove, che arricchiscono il patrimonio alpinistico omanita e rappresentano un ulteriore stimolo per la conoscenza di un territorio che si presta particolarmente all'arrampicata su pareti di varia lunghezza e di vario impegno ma sempre su roccia di qualità.
Riportiamo di seguito le relazioni originali dei nuovi itinerari aperti dal gruppo dell'Eagle Team
1 - Via "Old style" scarica la relazione in formato pdf
Al Hamra Tower - East summit - Parete Nord
175 m; VI
22/02/2025 - Florit Mauro e Leardi Francesco

Relazione:
Attacco all’estrema destra della parete su un ripiano con ometto.
L1 - Placca appoggiata fino sotto grandi tafoni che si superano a sinistra con passaggio atletico, proseguire per facile fessura e successiva placca appoggiata fino alla base di un diedro giallo. Sosta su spuntone. 45 m IV, V+, IV+
L2 - Dalla sosta traversare a sinistra e mirare ad una fessura che porta sotto uno strapiombo che si evita traversando a sinistra fino ad arrivare in un diedro che si segue sino ad un arbusto con spuntone per sosta. 45 m IV, V+, IV+
L3 - Traversare a destra per imboccare una fessura atletica ma ottimamente appigliata (usato un chiodo, tolto) fino a raggiungere il filo dello spigolo che si risale per altri 10 metri fino alla sosta su spuntone. 30m VI-, IV
L4 - Dalla sosta in obliquo ascendente verso sinistra fino ad un cordone (già presente) poi in verticale per bellissima placca lavorata fino ad arrivare con un passo delicato in una rampa camino che porta alla sosta su due fix. 40 m IV+, VI, V
L5 - Tratto in comune con la via "en attendant les Lents". 15 m 6a
Discesa a piedi come per le altre vie
Note: Bella via su roccia ottima. La via è facilmente proteggibile con una serie di friend. La parete è all’ombra fino al pomeriggio. L'ultima lunghezza è in comune con un itinerario a fix "En attendant les Lents".


2 - Via "Evening coffee" scarica la relazione in formato pdf
Jabel Fokha – East Summit
180 m; VIII+ max
22/02/2025 - Riccardo Volpiano e Marco Cocito
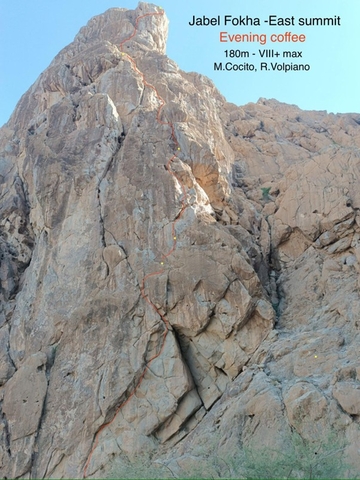
Relazione:
L1 - Attaccare l'evidente fessura ad arco rovescia verso dx e seguirla fino ad un grosso diedro camino che si segue verso sx. Dopo un ultimo ribaltamento, quando terminano le fessure, attraversare a dx in placca fino alla sosta con 2 spit. VIII+
L2 - Puntare a una fessura a dx, risalirla fino a quando si allarga e prosegue verso dx sotto un tetto fino a un blocco incastrato; da qui proseguire nella fessura soprastante fino a giungere su un terrazzo con un blocco enorme. Salire sopra il blocco e puntare ai buchi in alto a sx, aggirare lo spigolo a sx ed entrare in un buco enorme. Dal buco uscire a dx e per facile placca giungere in sosta a dx alla base di un diedro fessurato (spit + friend). VI+
L3 - Risalire internamente il diedro fessurato poi seguire lungamente il facile spigolo sulla sx senza entrare nel canale alla sua dx. Sosta sulla cengia al termine dello spigolo da attrezzate su masso. VI poi IV
L4 - Puntare all' evidente fessura orizzontale soprastante e seguirla verso dx fino a quando un esile fessurino verticale permette di ribaltarsi al di sopra. Traversare ancora a dx ed entrare nel diedro canale. Risalirlo brevemente fino ad individuare una serie di buchi e 2 clessidre sulla destra. Raggiungere la seconda clessidra e poi traversare lungamente verso dx in orizzontale o in leggera discesa, fino a quando un diedrino fessurato permette di uscire sul plateau sommitale. Sosta da attrezzare su friend su cannellures. VII
Discesa evidente a piedi aggirando la parete.

 Riki su evening coffe
Riki su evening coffe
Note: La sera prima della via un gruppo di 10 omaniti ci è venuto a trovare presso il nostro accampamento e ci ha offerto 2 thermos di caffè. Inizialmente un po' spaventato ci siamo resi conto che è invece una usanza locale offrire caffè agli estranei anche se le uniche parole inglesi che conoscevano erano coffee e yes. Questa via è dedicata a loro e al fatto che il primo tiro ti dà una bella sveglia come il caffè. Una bella esperienza, senza utilizzo di spit se non per le prime 2 soste. Una linea autonoma se non per brevi tratti in comune con altre vie, un traverso finale esposto e molto panoramico.
3 - Via “Habibi” scarica la relazione in formato pdf
Wadi Misfat Al Abriyeen - Eid Mubarak
120 m; V+
25/02/2025 - Mauro Florit e Francesco Leardi

Relazione:
L1 - Una splendida placca lavoratissima di roccia scura porta ad un terrazzo, poi uno speroncino e facili placche. Sosta su ponte naturale con cordino per calata lasciato. 45 m IV+
L2 - Salire direttamente ad una piccola pianta poi per placche lavorate si giunge ad un'ampia cengia che si percorre verso destra con passo del gatto per una decina di metri fino ad un masso incastrato nel diedro. 30m IV
L3 - In verticale per qualche metro poi traversare a sinistra per bellissime lame. Con leggero obliquo a sinistra fino al termine delle difficoltà. 45 m V+, IV+
Discesa: traversare sul bordo della parete verso sinistra fino sulla verticale del diedro sottostante. Doppia da 30 m attrezzata su arbusti fino all'ampia cengia. Seconda doppia da 20 m attrezzata su grande blocco porta alla sosta del primo tiro. Terza doppia da 45 m porta alla base.
Note: Corta ma bella vietta su roccia ottima. L'attacco si trova al centro della placca compatta circa 40 metri a destra del grande diedro. Ometto alla base. Discesa in doppie attrezzate.
 In apertura al Wadi Misfat Al Abriyeen
In apertura al Wadi Misfat Al Abriyeen
4 - Via "Feel free to create" scarica la relazione in formato pdf
Wadi Misfat Al Abriyeen
120 m; 6c max 6a+ obb
25/02/2025 - Riccardo Volpiano ed Erica Bonalda

Relazione:
L1 - attaccare la placca a gocce e erosioni sulla verticale di un gruppo di cespugli fino a uno spit. Superarlo e poi seguire dei facili gradoni verso sx fino a giungere su un terrazzo con un grosso blocco al di sopra del quale si trova la sosta su due spit. 5
L2 - attraversare a sx e infilarsi nel bucone, poi alzarsi verso sx puntando al buco grande successivo. Continuare dritto sfruttando le fessure presenti fino a raggiungere una zona più abbattuta che permette di traversare verso sx puntando ad una evidente rampa fessura che permette di raggiungere una pianta. Sosta su friend. 6a+
L3 - traversare a dx fino ad una grossa clessidra alla base di un diedrino fessurato con 2 piccoli buchi. Risalirlo brevemente e ribaltarsi sulla placca a dx e risalirla fino a un terrazzino. Superare il muro successivo (spit) e proseguire dritti fino in sosta a spit posta vicina a un albero. 6a+
L4 - ribaltarsi nel diedro svaso a sx della sosta fino a entrare nella grossa nicchia soprastante. Traversare a dx fino a un fessurino con arbusto che permette di ribaltarsi al di sopra e superare un blocco appoggiato verso dx. Da qui proseguire dritti senza percorso obbligato fino in cima. Sosta su friend. Passo di 6c/A0 poi 6a
Discesa: individuare la sosta di calata in basso dietro a un grosso blocco a sx (faccia a monte). Da lì doppia fino a S3, poi S1, terra
Note: Sentirsi liberi di scegliere la propria linea su una parete vergine e soprattutto di "creare" le prese necessarie per superare il passo chiave e non solo. Infatti in alcuni punti la roccia ha richiesto di essere bonificata e tra una martellata e l'altra si sono rotte le prese fragili e consolidate quelle fondamentali. Abbiamo aperto la via seguendo le linee di debolezza e soprattutto la roccia migliore e più solida. Per Erica la sua prima via aperta dal basso con il trapano (usato comunque con moderazione, solo 2 spit di progressione e alcune soste). Anche prima volta che io e Erica ci leghiamo in cordata insieme. 4 lunghezze con difficoltà costanti e moderate, con un solo passo più difficile. Roccia dal grip eccellente, a tratti eccessivo, che richiede a volte attenzione. Panorama dalla vetta sulla bellissima oasi all'inizio del canyon dove si trova la parete. Sfuggiti al caldo torrido completando la via giusto in tempo, prima che la parete si illuminasse.

5 - Via “Sciugomano” scarica la relazione in formato pdf
Parete Ovest del canyon
115m; 7c+max - 6c obb
Materiale: 1 serie completa di totem, completando con un micro 0.1, 3 e 4 per la sosta sotto il tetto.
25/02/2025 - Matteo Monfrini, Lorenzo Toscani e Marco Cocito

Relazione:
Avvicinamento: da Al Hamra parcheggiare nei pressi del Misfat Alabriyyn visitor car parking. Proseguire a piedi verso il canyon andando verso Nord. Camminare per 15/20minuti avendo cura di attraversare sul lato ad Ovest del canyon puntando ad un evidente strapiombo a centro parete.
La linea segue un sistema di fessure per il primi due tiri per poi vincere uno strapiombo tecnico. La via presenta spit solo dove non è stato possibile proteggere diversamente.
L1 - Seguire la logica fessura fino a fare sosta su spit. 6a+ 30m
L2 - Continuare per fessura e poi per roccia gialla sulla sinistra. Sosta a friend sotto il tetto. 6b 30m
L3 - Uscire dal tetto con passo atletico per poi affrontare un passaggio tecnico. Concludere il tiro obliquando verso sinistra per poi raddrizzare. Sosta su spit. 7c+ 30m
L4 - Proseguire per facili roccette per poi fare sosta a friend fuori dalle difficoltà. III 25m
Discesa: proseguire a sinistra per trovare una linea di soste attrezzate sulla via adiacente. La prima calata si trova nei pressi di un albero, sotto un grosso masso. Consiglio di fare tutte le calate per non fare impigliare le corde sulla roccia estremamente abrasiva.
Note: È sconsigliato unire i tiri per via dell'attrito delle corde.

6 - Via “Dreaming the tower” scarica la relazione in formato pdf
Jabel Kawr - Said Wall - Parete Nord
400 m + 250 di zoccolo; VI
27/02/2025 - Riccardo Volpiano e Mauro Florit

Relazione:
Avvicinamento: dal termine della strada sterrata salire senza via obbligata verso la base della torre. Giunti sotto la verticale si nota un'ampia cengia che percorsa facilmente verso sinistra porta al filo della cresta. Salire senza via obbligata puntando alla base della torre. Passi 2 grado.
L1 - Salire il sistema di fessure a sinistra delle erosioni tafonate rosse 30m. Sosta su arbusto V
L2 - Continuare per splendida placca lavorata. 30m. Sosta su arbusto IV+
L3 - Salire direttamente puntando alle erosioni tafonate al centro del pilastro. 50m. Sosta su clessidra. III+
L4 - Obliquare a destra per una bella rampa lavorata. 50m. Sosta su friend. V-
L5 - Ancora dritti per la rampa fino al filo dello spigolo in un ampio terrazzo 45m. Sosta clessidra V-
L6 - Salire il filo dello spigolo fino alla cima della torre 40 m. Sosta su spuntone. VI
 Marco in apertura sul primo tiro di Drips of joyDalla cima scendere in doppia verso la sottostante forcella. Spostarsi sotto la parete principale alla base di un tetto fessurato.
Marco in apertura sul primo tiro di Drips of joyDalla cima scendere in doppia verso la sottostante forcella. Spostarsi sotto la parete principale alla base di un tetto fessurato.
L7 - Salire la fessura a destra del tetto poi continuare per placche abbattute. 55m sosta su friend. V+ poi IV
L8 - Diedrino poi placche facili. 55m. Sosta su friend. V poi IV
L9 - Ancona facili placche fino al termine delle difficoltà. 50 m IV
Discesa: salire in obliquo verso destra puntando alla base di una grande torre. Traversare sempre verso Ovest sul ciglio della parete. Non ci sono ometti ma seguendo la logica di discesa si accede ad un ampio canale detritico. Con due doppie da 30 m su alberi non attrezzate si perviene alla base dell’immensa e ripida parete del Said Wall.
Note: Bella via di stampo classico che raggiunge prima l'evidente torre staccata che si stacca dall'immensa parete del Said Wall. Poi con una corda doppia si raggiunge facilmente il colle da dove con altre tre belle lunghezze di corda si arriva al termine delle difficoltà.
7 - Via “Drips of Joy” scarica la relazione in formato pdf
Jabel Kawr – Said Wall – Al Kumeira
500 m; 7b max-7a obb
Materiale: serie completa di Totem, microfriend, doppi medi fino al #3 e un #4
01-02/03/2025 - Marco Ghisio, Matteo Monfrini e Riccardo Volpiano

Relazione:
Avvicinamento: da Al Kumeira, seguire la cresta fino a un altipiano (1h 30min), si affronta quindi lo zoccolo seguendo il terreno più semplice con passaggi di III/V.
L1 – 60m, 7b. Superare un breve strapiombo su fessura gialla lavorata, poi seguire una fessura sotto un tetto. Rimontare nel diedro fin sotto un tettino, quindi traversare a sinistra superando uno spigolo. Continuare su placca fino alla sosta (1 spit + possibile micro). Possibile sosta intermedia all'inizio del diedro su friend.
L2 – 30m, 6c (3 spit). Sequenza verticale su tacche nette, seguita da un traverso a destra lungo una fila di spit. Sosta su 2 spit.
L3 – 30m, 7a+ (1 spit). Traversare a sinistra su prese buone, ribaltarsi con passo difficile e salire dritti fino a una nicchia sotto un tafone. Sosta su friend nella fessura centrale.
L4 – 45m, 6a. Salire dritti fino a una comoda cengia, rimontare e proseguire a destra fino a una seconda cengia. Superare il tetto nel punto meno pronunciato e continuare dritto. Sosta su terrazzo, su friend.
L5 – 45m, 6b+. Seguire due spit su placca a gocce, poi proseguire dritti fino a una piccola cengia. Sosta su friend (#3 e #4).
L6 – 50m, VI/6a. Traversare a destra puntando una pianta, poi salire verso una nicchia tra grandi tafoni. Sosta su friend (#1 + #1).
L7 – 45m, 6b/VI+. Uscire a sinistra dei tafoni, quindi proseguire dritti lungo fessure e lame. Ribaltarsi sulla rampa a sinistra e salire fino alla nicchia più alta. Possibile sosta intermedia su albero per recupero saccone.
L8 – 45m, V+. Obliquare a sinistra, poi raddrizzarsi. Superare un piccolo tetto e proseguire dritti. Sosta su pianta.
L9 – 30m, V. Aggirare a destra il diedro soprastante, poi obliquare a sinistra fino alla cresta finale. Sosta su clessidra e friend #1.
L10 – Circa 200m, III. Proseguire obliquando a sinistra fino alla cima.
 Via Drips of Joy discesa
Via Drips of Joy discesa
Discesa: dalla fine della via, traversare a mezza costa fino all’anfiteatro tra la parete salita e Said Wall. Scendere il secondo canale fino a una gola con salto di roccia, quindi traversare a sinistra fino a un albero inclinato per una doppia da 40m (o 30m + disarrampicata). Dalla spalla rocciosa, proseguire a sinistra costeggiando la parete, poi disarrampicare un canale fino a una zona più abbattuta. Seguire le cenge esposte fino a una cengia più ampia che traversa a destra, restringendosi progressivamente. Dopo un tratto stretto ed esposto, raggiungere un albero per una doppia da 30m. Dalla base, traversare in diagonale verso destra fino alla dorsale che riporta al pianoro e ad Al Kumeira (2h).
Note: Affascinati dall’estetica dei tafoni nella parte alta, Marco Ghisio, Matteo Monfrini e Riccardo Volpiano hanno aperto una nuova via dal basso su un pilastro dello Jabel Kawr, Al Kumeira Wall. Dopo aver superato una fessura strapiombante ad arco appena sopra lo zoccolo, si sono trovati davanti a muri a gocce super compatte, che hanno reso la scalata impegnativa e di grande soddisfazione. In apertura la via ha richiesto il bivacco in parete. La via parzialmente attrezzata, con spit solo nei passaggi chiave. Soste su friend o alberi, salvo dove diversamente indicato. Possibili soste intermedie per una progressione più comoda con il saccone.

8 - Via “Patatonia” scarica la relazione in formato pdf
Jabel Al Wal - Parete Ovest
250 m; VII
01/03/2025 - Lorenzo Toscani, Marco Cocito, Mauro Florit e Francesco Leardi

Relazione:
Avvicinamento: seguire la diramazione verso il Wadi Damm della strada asfaltata a sud del Jabel Misht che collega Al Ayn a Sint. La traccia porta fino sotto alla parete (23.1731457N, 57.0284205E). Dal parcheggio in circa 20 minuti si arriva all'attacco. La linea di salita è la colata bianca di sinistra, più larga e meno evidente di quella di destra. Ometto alla base.
L1 - Dal chiodo ad anello arancione salire il diedrino alla sua sinistra e per splendida placca lavorata si arriva in sosta alla base del canale. Sosta su uno spit rock 45m IV
L2 - In obliquo a destra per rampa fino a poterne uscire a destra su bellissima roccia articolata. Ancora a destra per una fessura che porta sulla cima di un pilastro. 45m V+ sosta su uno spit rock.
L3 - traversare orizzontalmente a sinistra, chiodo lasciato, per 10 m fino ad un ponte naturale con cordino azzurro, poi in verticale per altri 15 m fino alla sosta su uno spit rock . Lasciato un nut incastrato. 25m 7, poi V+
L4 - Salire la fessura a sinistra della sosta puntando poi al camino che va risalito fino al ballatoio di sosta con uno spit rock 45m V
L5 - Salire la fessura a sinistra fino al suo termine, poi per splendida placca lavorata si giunge alla sosta su cengia inclinata. Sosta da attrezzare su friend e nut lasciato. 30m VI+
L6 - Rimontare la placca ascendente verso sinistra fino ad una fessura articolata che torna leggermente a destra e punta ad un camino. Sosta su un chiodo. 60m IV+
Discesa: dall'ultima sosta salire per sfasciumi al termine della parete. Proseguire per la pietraia verso est e scendere all'oasi. Seguire poi la strada sterrata a sinistra per rientrare al parcheggio.
Note: Bellissima via che percorre la probabilmente mai salita parete del Jabel Al Wal. (toponimo fornito da un pastore locale) Le soste sono rimaste attrezzate.

9 - Via “Dattero d'oro” scarica la relazione in formato pdf
Jabel Al Wal - Parete Ovest
220 m; difficoltà VII
03/05/2025 - Marco Ghisio, Mauro Florit e Francesco Leardi

Relazione:
Avvicinamento: seguire la diramazione verso il Wadi Damm della strada asfaltata a sud del Jabel Misht che collega Al Ayn a Sint. La traccia porta fino sotto alla parete (23.1731457N, 57.0284205E). Dal parcheggio in circa 20 minuti si arriva all'attacco. La linea di salita è evidenziata, nella prima parte, da un diedro ascendente verso destra e nella parte alta da uno strapiombo fessurato di roccia rossa con una marcata fessura grigia. Entrambi questi punti significativi non verranno toccati dalla linea ma rimangono alla destra dell'itinerario.
L1 - Attaccare sotto la verticale del sopracitato diedro una fessura e salire il successivo caminetto con arbusto. Proseguire per il camino fino a uscirne sulla destra su un ballatoio. 40m V sosta su un fix.
L2 - Traversare in obliquo verso sinistra per bei muretti. 25m IV+ sosta su albero con cordone lasciato.
L3 - Salire direttamente dalla sosta un muretto atletico, poi per placche più facili giungere ad un ampio terrazzo. 45 m V+ IV+
L4 - Qualche metro a destra della sosta salire per splendida placca fessurata e successivo diedro. 30m VI+ sosta su un fix.
L5 - In obliquo a sinistra per qualche metro poi ritornare a destra in un bel diedro fessurato che va seguito fino a dove è possibile traversare a sinistra sul filo dello spigolo. 30m VI+ sosta su un fix.
L6 - Diritti per fessure accennate poi a sinistra ad un fix. Poi salire verticalmente e traversare a destra su un ampio pulpito. 20m VII- sosta su un fix.
L7 - Salire le lame con arbusti fino ad un terrazzo sulla destra ove terminano le difficoltà. 15m V+ sosta su friend.
Salire senza via obbligata per roccette di II grado fino al termine della parete.
Discesa: dalla sommità abbassarsi verso sud seguendo la dorsale fino ad imboccare verso nord (direzione strada) una serie di gradoni erboso rocciosi leggermente in obliquo verso destra e tenendosi ad una cinquantina di metri dal ciglio della parete (ometti). In prossimità del limite della parete traversare verso est (ometti) su vaghe tracce costeggiando il ciglio della parete che volge verso la strada. Da un evidente ripiano con ometto scendere lo speroncino sottostante con qualche facile passaggio per circa 30/40 metri fino ad un ulteriore ripiano che diventa poi cengia che si segue verso Ovest (sinistra di discesa) degradando verso la pietraia sottostante. Brevemente ritornare alla strada e quindi al parcheggio per facili pendii. Dalla sommità 40/45 min
Note: Bellissima via che percorre la probabilmente mai salita parete del JABEL AL WAL. (toponimo fornito da un pastore locale) Le soste sono rimaste attrezzate.
10 - Via "All you need is a date” scarica la relazione in formato pdf
“Perché in Oman qualsiasi problema può essere risolto con un dattero e perché la via è talmente bella che potrebbe essere un'ottima proposta per il primo appuntamento con una ragazza…”
Wadi Nakhr - Lato Nord-Est
120 m, 6a max
Materiali: doppia serie di friend fino al 4, un micro friend per la partenza di L2.
04/03/2025 - Marco Ghisio e Riccardo Volpiano

Relazione:
L1 - Attaccare sulla verticale dell'evidente pilastro staccato, risalire la prima facile placca fino a raggiungere il diedro fessurato. Seguirlo superando 2 piantine, dopo la seconda entrare nel diedro a sinistra formato dal pilastro staccato e seguirlo fino al suo termine. Sosta a spit , 6a, 50 m
L2 - Salire la placca sovrastante più facile delle apparenze con roccia unica. Quando si abbatte obliquare a dx. Sosta a spit sulla verticale dell'evidente grotta soprastante. Sosta 2 spit, 6a, 40 m
L3 - Traversare a sx e risalire il magnifico pilastro a cannellures rosse fino a entrare in un ultimo facile diedro fessurato. Sosta spit +clessidra 5, 30 m
Discesa: doppie S3 - S1, S1 - terra
11 - Via “Pole Crack” scarica la relazione in formato pdf
Wadi Nakhr - Lato Nord-Est
120 m, 7a max
Materiale: doppia serie di friend fino al 4
04/03/2025 - Marco Ghisio e Riccardo Volpiano

Relazione:
L1 - Attaccare a sx del palo mirando ad un evidente gradone fessurato, alla base di una fessura strapiombante obliqua da dx a sx. Sosta fix + nut , 6a, 20 m
L2 - Risalire internamente la fessura obliqua soprastante. Sosta fix+anello, 7a, 30 m
L3 - Risalire il diedro fessurato a sx e poi la fessura di dita strapiombante alla sua dx. Ribaltarsi sul terrazzo, risalire il diedro a sx, poi aggirare a dx lo spigolo di roccia super abrasiva e mirare alla sosta su clessidra in alto. 6c, 30 m
Discesa: doppie S3 - S1, S1 - terra
Note: una via tutta in fessura che inizia nei pressi di un grosso palo metallico appoggiato alla roccia.
 Marco G sul secondo tiro di Pole crack
Marco G sul secondo tiro di Pole crack
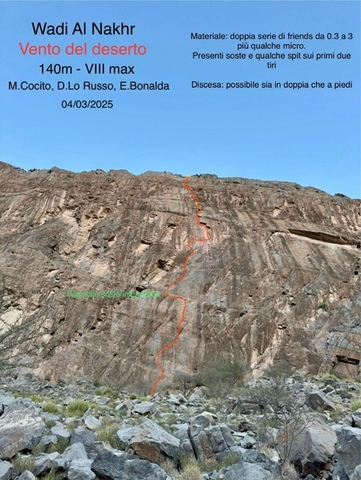
12 - Via “Vento del deserto” scarica la relazione in formato pdf
Wadi Nakhr - Lato Sud-Ovest
140 m; VIII max
Materiale: doppia serie di friend dallo 0,3# al 3#, più qualche micro
04/03/2025 – Marco Cocito, Daniele Lo Russo ed Erica Bonalda
Note: presenti soste e qualche spit sui primi due tiri.
Discesa possibile sia a piedi che in doppia.
Assemblea primaverile gruppo Orientale CAAI 17 Maggio 2025 Ravina (TN)
di Francesco Leardi Presidente C.A.A.I. Gruppo Orientale
In un contesto territoriale dove si respira montagna a tutto tondo si è svolta il 17 Maggio 2025 l’assemblea primaverile del gruppo Orientale del CAAI.
Grazie alla gentile disponibilità della Sezione della S.A.T.di Ravina abbiamo avuto a disposizione una funzionale location ma non solo; con la efficace organizzazione del Presidente Simone Navarini, della Vicepresidente Caterina Mazzalai , del nostro collega accademico Giorgio Espen e di svariati collaboratori il successo dell’evento è stato notevole.
La partecipazione è stata numerosa con ben 57 presenze per una serie di proposte dell’ODG assai interessanti.
Ovviamente ho ringraziato la presenza di Carlo Claus che con i suoi 99 anni è un esempio per il sodalizio di passione, dedizione e simpatia.
Grazie Carlo da tutti noi!
 Da sinistra i membri dell'Eagle Team: Riccardo Volpiano, Daniele Lo Russo, Dario Eynard accademico, Erica Bonalda, Iris Bielli, Alessandra Prato, Lorenzo Toscani, Matteo Monfrini. Quindi Matteo della Bordella, Mauro Florit e Francesco Leardi - Ph A. Rampini.
Da sinistra i membri dell'Eagle Team: Riccardo Volpiano, Daniele Lo Russo, Dario Eynard accademico, Erica Bonalda, Iris Bielli, Alessandra Prato, Lorenzo Toscani, Matteo Monfrini. Quindi Matteo della Bordella, Mauro Florit e Francesco Leardi - Ph A. Rampini.
La nostra assemblea è stata programmata in concomitanza con il Sarca Climbing Meet di Arco per due motivi: il primo per riunire in un unico periodo di giorni e permettere l’integrazione dei giovani partecipanti del meeting con le esperienze dei componenti del C.A.A.I. Orientale, e non solo, e il secondo per sancire il termine del primo progetto C.A.I. Eagle Team ideato e sviluppato da Matteo Della Bordella e vari collaboratori, tutti alpinisti di alto livello.
Il primo passo dell’assemblea è stato presentare i giovani partecipanti del progetto C.A.I. Eagle Team selezionati da Matteo Della Bordella e il gruppo direttivo, progetto che ha visto il suo compimento finale nelle destinazioni della Patagonia e dell’Oman con vari successi alpinistici.

 Dopo una esposizione del progetto ormai concluso e del futuro, che sta prendendo piede, Della Bordella ha chiamato accanto a se i ragazzi dell'Eagle Taem.
Dopo una esposizione del progetto ormai concluso e del futuro, che sta prendendo piede, Della Bordella ha chiamato accanto a se i ragazzi dell'Eagle Taem.
Il nostro collega Mirco Grasso ci ha permesso di vivere con lui, Matteo e Dario le emozioni della loro salita del Cerro Piergiorgio con le suggestive foto che hanno suscitato grande interesse.
Un successo del C.A.I. Eagle Team che ha visto il completamento dell’itinerario seguito e sfortunatamente non completato per l’arrivo di una perturbazione ad opera del nostro collega Maurizio Giordani, presente in sala, e del compagno di cordata Luca Maspes (Rampikino).
Dopo questo momento di intensa atmosfera alpinistica è iniziata la nostra assemblea che non andrò a riferire nei contenuti strettamente istituzionali ma solamente in alcuni punti salienti ai quali tengo molto.
Purtroppo c’è stato il momento del ricordo dei soci defunti Fermeglia, Baldi, Bellini, Mastracci, Valdo, Prati, e recentemente Piero Fina.
Erano presenti in sala le figlie di Piero, Alessandra e Donata dalle quali sono stato incaricato di leggere un ricordo del papà che riporto di seguito:
Nato il 17 settembre del 1930 ci ha lasciati il 15 aprile 2025.
I suoi primi approcci con la montagna “vera” risalgono all'anno 1950 quando sale sulla cima del Monte Pelmo grazie ad una gita organizzata dalla Giovane Montagna e sulla cima Grande di Lavaredo con Nerone Balasso.
L’anno successivo si iscrive alla sezione C.A.I. di Vicenza.
 Sei Accademici vicentini che hanno contribuito alla storia dell’alpinismo italiano: da sinistra Tarcisio Rigoni, Piero Fina, Adriana Valdo, Andrea Colbertaldo, Gastone Gleria, Piergiorgio Franzina - Ph Arch Fam FinaNasce così la sua passione per l'arrampicata che lo porta a frequentare la palestra di Gogna ed è lì che conosce Silvano Pavan e Berto Brotto con i quali avrà il battesimo definitivo della roccia, instaurando un'amicizia durata una vita.
Sei Accademici vicentini che hanno contribuito alla storia dell’alpinismo italiano: da sinistra Tarcisio Rigoni, Piero Fina, Adriana Valdo, Andrea Colbertaldo, Gastone Gleria, Piergiorgio Franzina - Ph Arch Fam FinaNasce così la sua passione per l'arrampicata che lo porta a frequentare la palestra di Gogna ed è lì che conosce Silvano Pavan e Berto Brotto con i quali avrà il battesimo definitivo della roccia, instaurando un'amicizia durata una vita.
Ecco allora le prime salite sulle Piccole Dolomiti (Pilastro Solda' del Baffelan) e sulle Pale di San Martino (Spigolo del Velo).
Dopo un periodo di attività ridotta a causa del servizio militare e impegni di lavoro nella metà degli anni 50, riprende ad arrampicare in maniera costante con l'inizio degli anni 60, salendo alcune classiche delle Dolomiti al tempo considerate molto difficili, come lo Spigolo dell'Agner, la Rittler-Videsott-Rudatis alla Busazza, la Comici-Casara sul Salame del Sassolungo (prima ripetizione vicentina con Bepi Peruffo), la Solleder del Civetta e per finire la Cassin alla Ovest di Lavaredo ed il Diedro Livanos alla Su Alto, entrambe effettuate con Piergiorgio Franzina in tempi record per l'epoca.
Grazie a questa attività Gastone Gleria proporrà il suo ingresso nel Club Alpino Accademico Italiano dove viene ammesso nel 1969.
Negli anni seguenti l'attività di Piero Fina si apre ai percorsi di ghiaccio (Canalone Neri di Cima Tosa, Canalone Oppel all'Antelao, Nord della Presanella, Nord Monte Cercen, Nord Punta Thurwieser) e alle vie di misto in alta quota nelle Alpi Occidentali (Monte Cervino, traversata del Lyskamm, Cresta Signal sul Monte Rosa, Cresta di Rochefort e Cresta dell'Innominata sul Monte Bianco).
Notevole anche la pratica nel periodo invernale-primaverile dello sci alpinismo, dall'esplorazione più che decennale del gruppo dei Lagorai alle classiche della catena di confine, ai “4000” Svizzeri.
Per Piero là montagna non è mai stata sinonimo di individualismo, ma di condivisione e di amicizia.
Le salite effettuate non sono per lui solo uno sterile elenco di obiettivi raggiunti, ma un insieme di ricordi e di episodi vissuti in compagnia di amici.
Inoltre ha sempre amato mettere la sua esperienza e la sua conoscenza a disposizione dei più giovani o meno esperti che volessero approcciarsi alla montagna, in modo che potessero godere di quanto questa può offrire.
Da questo deriva il suo impegno a livello sezionale che, oltre a portarlo a far parte del consiglio direttivo e soprattutto ad assumere la carica di Presidente dal 1984 al 1988, lo ha visto come responsabile di numerose gite da lui organizzate sia in ambito escursionistico che alpinistico che sci-alpinistico (da ricordare tra le altre il Pizzo Badile per il Canalone Sud, la salita all'Allalinhorn e all'Alphubel nelle Alpi Svizzere e la Traversata delle Calanques da Marsiglia a Cassis).
La sua attività con il tempo è andata inevitabilmente a ridimensionarsi, ma la sua passione per la montagna è sempre stata viva.
Anche io come presidente ricordo la sua figura, affabile e severa al tempo stesso, sempre lucido analista dell’alpinismo di ieri e dell’oggi.
Immancabile negli ultimi tempi, la mail di giustificazione per l’assenza alle nostre riunioni, segno tangibile di un profondo rispetto e amore per il sodalizio
INTERVENTO AL FUNERALE DI ALESSANDRA E DONATA
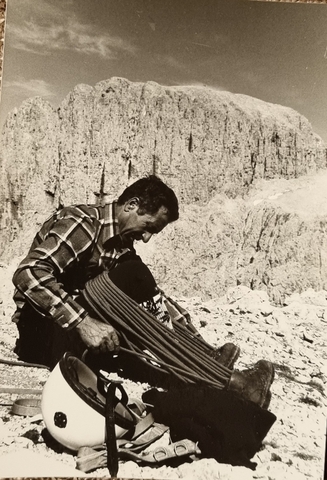 Piero Fina - Arch. fam. FinaHai affrontato la tua ultima salita con lo spirito che ti ha sempre contraddistinto, con serenità, senza mai lamentarti per le difficoltà, e riconoscente verso chi ti aiutava godendo fino alla fine delle piccole cose che ti erano ancora concesse.
Piero Fina - Arch. fam. FinaHai affrontato la tua ultima salita con lo spirito che ti ha sempre contraddistinto, con serenità, senza mai lamentarti per le difficoltà, e riconoscente verso chi ti aiutava godendo fino alla fine delle piccole cose che ti erano ancora concesse.
Sotto quella scorza che poteva sembrare un po' da duro, nascondevi un gran cuore che mettevi in tutto quello che facevi, sempre disponibile verso tutti, dal voler condividere la tua passione per la montagna con persone meno esperte, al voler essere di supporto, una volta andato in pensione, ad amici e parenti che ne avessero bisogno.
Io e Donata ti ringraziamo per averci trasmesso i valori che hai sempre perseguito nella tua vita: la passione per tutto quello che facevi, dal lavoro alla montagna, il rispetto degli impegni presi e la coerenza sempre mantenuta.
Ti ringraziamo inoltre per averci dato assieme alla mamma l'immagine di una unione solida che è andata consolidandosi nel tempo e che avrebbe presto raggiunto i 71 anni.
Se pensiamo ora a te, ti immaginiamo a guardare da lassù le tue montagne, assieme ai tuoi amici che hai raggiunto, ricordando le tante avventure vissute insieme.
Sullo sfondo scorrevano le immagini di Piero ma soprattutto la prima è quella che mi ha colpito maggiormente che inquadra ben 6 accademici vicentini che hanno contribuito alla storia dell’alpinismo italiano ; da sinistra Tarcisio Rigoni, Piero Fina, Adriana Valdo, Andrea Colbertaldo, Gastone Gleria, Piergiorgio Franzina.
E’ iniziata così la parte burocratica della quale descrivo alcuni punti di interesse generale.
In occasione dei 100 Anni Solleder Lettembauer 7 Agosto 1925 il nostro collega Baù ci informa che per ricordare questa tappa importante dell'alpinismo, si è pensato di celebrare la salita il weekend del 27-28 settembre 2025.
Sabato 27 settembre ci saranno vari eventi: nel pomeriggio un dibattito tra gli alpinisti che hanno maggiormente frequentato la nord ovest, dando importanza alla parete e a questa via. Sarà l'occasione per presentare anche la nuova guida del Civetta che Baù sta completando con Luca Vallata e sarà pubblicata prima dell'estate.Verrà anche proiettato il documentario di Emanuele Confortin sulla Solleder Lettembauer attualmente in lavorazione. Altri contributi sono in progetto e lavorazione.
In collaborazione con la fondazione DOLOMITI UNESCO il nostro nuovo collega Emanuele Confortin sta sviluppando il progetto “Dolomitismo, racconti verticali” che consiste in una docuserie di 9 episodi della durata di 28 minuti circa, realizzati con un format originale, il cui scopo è approfondire la scoperta delle Dolomiti attraverso il punto di vista degli alpinisti.
La struttura narrativa di ciascun episodio prevede degli elementi in comune:
- un capo cordata (Luca Vallata, guida alpina);
- un ospite (alpinista maschile o femminile, preferibilmente giovane, con un legame con la parete che si andrà a scalare);
un alpinista che fungerà da mentore per il Gruppo e/o la parete su cui si scalerà;
- il contributo di Gigi Dal Re, artista e alpinista che disegnerà le vie e le cime scalate;
- un geologo che creerà il contesto per conoscere (oltre alla storia) la genesi di queste meraviglie che sono le Dolomiti;
Le vie scelte per questa prima serie sono:
- via Eisenstecken-Rabanser-Pircher a Cima Mugoni (Catinaccio)
- via Aste-Susatti a Punta Civetta (Civetta)
- via Alverà-Menardi al Cason di Formin in inverno (Lastoi di Formin)
- via normale al Campanile Basso (Brenta)
- traversata Comici “con spaccata” nei Cadini di Misurina (Cadini)
- via Solleder-Kummer al Sass Maor (Pale di San Martino)
- via Casarotto-Radin allo Spiz di Lagunaz (Pale di San Lucano) … per il 50esimo dell’apertura
A proposito di Pierino Radin ricordo che il 1 Maggio a Trento in occasione degli eventi del Trento film festival è stato insignito, assieme al trentino Davide Sassudelli, dell’ambito premio del Chiodo d’oro conferito dalla sezione SOSAT di Trento nel progetto che, ricordo, vede il contributo del gruppo Orientale del C.A.A.I.
- via del Cinquantenario FISI (via Gogna-Dorigatti-Giambisi-Allemand) in Punta d’Ombretta (Marmolada)
- via Gherbaz-Candot alla Croda Cimoliana (Dolomiti Friulane)
Devo ringraziare Alberto Rampini per il suo impegno nel gestire il sito.Serafino Ripamonti del gruppo Occidentale in questo momento si sta occupando della comunicazione a media e testate.Tra l’altro anche grazie ad Inselvini, presidente del gruppo Centrale si sta procedendo ad inserire il C.A.A.I. sulla piattaforma Instagram.
Si è quindi svolta la presentazione ufficiale dei nuovi colleghi accademici con la rituale consegna della tessere e distintivi.
 I nuovi Accademici. Da sin Emanuele Confortin, Andrea Micheletto, Claudia Mario, Stefano Luisetto e Marco Gnaccarini - Ph Archivio BordignonEmanuele Confortin, presentato da Francesco Leardi e Francesco Lamo, con la consueta verve che lo contraddistingue ci ha coinvolto nella sua soddisfazione a fare parte dell’Accademico e ha proiettato un “teaser” molto bello del progetto celebrativo del centenario della Via Solleder-Lettenbauer alla NW del Civetta.Molti progetti nel cassetto tra i quali l’ultimo appena completato e in distribuzione che è il docufilm, assai bello, su Renato Gobbato, al secolo “Bagnin”, Accademico del C.A.A.I. purtroppo scomparso nel 1980, un precursore, mi permetto di dire, dell’alpinismo moderno ed anche nelle sue idee un visionario;
I nuovi Accademici. Da sin Emanuele Confortin, Andrea Micheletto, Claudia Mario, Stefano Luisetto e Marco Gnaccarini - Ph Archivio BordignonEmanuele Confortin, presentato da Francesco Leardi e Francesco Lamo, con la consueta verve che lo contraddistingue ci ha coinvolto nella sua soddisfazione a fare parte dell’Accademico e ha proiettato un “teaser” molto bello del progetto celebrativo del centenario della Via Solleder-Lettenbauer alla NW del Civetta.Molti progetti nel cassetto tra i quali l’ultimo appena completato e in distribuzione che è il docufilm, assai bello, su Renato Gobbato, al secolo “Bagnin”, Accademico del C.A.A.I. purtroppo scomparso nel 1980, un precursore, mi permetto di dire, dell’alpinismo moderno ed anche nelle sue idee un visionario;
Marco Gnaccarini presentato da Ivo Maistrello e Ivan Maghella ci ha accompagnato sul suo percorso di vita personale e alpinistica con una pregevole serie di immagini.Indubbiamente serietà e professionalità sono qualità che non gli mancano così come l’impegno su vari fronti nelle scuole di alpinismo.Un eccellente “valore aggiunto” per il sodalizio;
Stefano Luisetto presentato da Francesco Leardi e Diego Toigo, come nel suo stile molto austero ha parlato a braccio distribuendo, almeno così ho percepito, la sua energia al gruppo.Certamente un alpinista di altissimo livello con tanti progetti futuri.Le caratteristiche più marcate in Stefano sono la caparbietà unita alla voglia di alpinismo con la “A” maiuscola;
Claudia Mario presentata da Alessandro Baù e Mirco Grasso alpinista, fisioterapista parlando di questioni tecniche e mamma della splendida Viola e moglie di Alessandro estrapolando la componente personale.
Ebbene ci ha deliziato di immagini bellissime del suo percorso alpinistico ma non solo, e concludendo molto simpaticamente che, contrariamente ai colleghi maschietti che sono in debito con le loro mogli e compagne, che portano infinita pazienza, Lei è sempre a “credito” dal buon Alessandro.E oserei dire chapeau!
Andrea Micheletto presentato da Ivo Maistrello e Sergio Antoniazzi forse il più emozionato; ed io, da osservatore esterno mentre parlava, ho ragionato sul fatto che è veramente straordinario sapere che nel suo percorso alpinistico ha aperto vie straordinarie, ingaggiose e su roccia spesso dalla qualità assai dubbia.Insomma, sotto un abito burbero e timido si cela un alpinista di alto profilo.Un onore averlo tra di noi:
Poi è stata la volta del mio vicepresidente Guido Casarotto che con un excursus piuttosto sintetico, lo avevo pregato di tralasciare l’inizio della trattazione dalle guerre puniche, ci ha illustrato l’andamento del Sarca climbing meet che insieme ad altri collaboratori ha portato avanti contestualmente alla nostra Assemblea di Gruppo.
Un impegno svolto con professionalità e precisione.Bravo Guido!
Dopo due anni di meeting di Arco con risultati più che soddisfacenti e grazie ai contributi ricevuti mi sono chiesto se non fosse stato il momento di cambiare, almeno per una edizione, la location.
Le notti insonni portano consiglio ma soprattutto lo sguardo sempre così sereno di Stefano Righetti e la sua disponibilità hanno avvalorato la mia idea: sarà Bismantova 2026!
Ringrazio il presidente del C.A.A.I. Mauro Penasa che ha pazientemente assistito ai nostri lavori con interventi che sinceramente mi sono stati di supporto.
Ringrazio chi ha collaborato nell’allestimento, accoglienza soci e preparazione gadget:Sandra Bordignon, Anna Terruzzin, Fiammetta Curcio che si è prestata anche al ruolo di verbalizzante , Giuliano Bressan e Giorgio Espen.
Ed ovviamente ringrazio i colleghi tutti.
Lo scorso 25 aprile, approfittando di condizioni eccezionalmente ancora “invernali”, l’Accademico Anselmo Giolitti, in cordata con Michele Tomatis, ha salito il Colatoio Est-Nord-Est del Monviso, aprendo uno degli itinerari di misto più impegnativi del gruppo.
CRUMBLING EMPIRE
di Anselmo Giolitti
La salita di questa bellissima nuova linea sul Monviso è la storia di un sogno che in breve si avvera! Ne intuisco la possibilità nei primi giorni di aprile di quest’anno, salendo al Viso Mozzo. Quella gita con gli sci mi dà la possibilità di vedere la nuova linea e valutarla da diverse angolazioni, prospettive, luci e con una vista imponente dall’alto dalla cima del Viso Mozzo.
 Una linea di sogno - Ph Arch A. Giolitti
Una linea di sogno - Ph Arch A. Giolitti
Nella settimana successiva era prevista, ed infatti è poi scesa, un’importante nevicata. Da valle ci si fanno tanti film… In questa stagione a quelle esposizioni molta neve seguita da gran caldo potrebbe significare fine dei giochi, ma una cosa che ho rilevato a favore è che la linea è poco esposta a pericoli oggettivi! Non ha un canale sopra e le pareti laterali sono di roccia abbastanza compatta! Insomma, cerco razionalmente di motivarmi, nel frattempo comincio a sentire alcuni possibili soci con la premessa che il primo giorno che riteniamo utile sotto l’aspetto condizioni e meteo bisognerà andare.
Una settimana dopo il giorno di Pasquetta ci regala una bellissima giornata in quota e quindi è un’ottima occasione per un ultimo sopralluogo. La sorpresa è che quella che era una linea discontinua, prevalentemente di misto la settimana prima, ora è una linea bianca continua da cima a fondo! Fantastica!
Tra i soci possibili, a districarsi tra problemi ed impegni vari c’è solo Michele, che però come me non riesce a liberarsi prima del 25 aprile. Sono solo tre giorni ma ora la linea è veramente evidente. Col bel tempo e il lungo ponte pasquale, non sia mai che, tra gli scialpinisti, ci salga anche un qualche alpinista affamato… Ci organizziamo per il venerdì e incrociamo le dita!
Anche in questa occasione, come per altre, decidiamo per la salita in giornata da valle e da casa, che significa sveglia tra l’una e le due, Michele infatti ha ancora un po' più di strada di me.
 In avvicinamento verso il colle di Viso - Ph Arch A. Giolitti
In avvicinamento verso il colle di Viso - Ph Arch A. Giolitti
Come da programma, alle 4 partiamo sci in spalla da Pian Regina. Dopo venti minuti, quando mettiamo gli sci ai piedi, già sentiamo sollievo nell’aver scaricato un po’ la zainata… Nonostante tutto, saliamo veloci e, verso le 6.15, siamo già sotto la parete NE.
La luce ci regala begli sguardi su tutte le linee che sono imbastite o formate sulle pareti del Monviso e del Visolotto. Tutto contribuisce a caricarci! Risaliamo un po’ sulla conoide e vediamo che si sono ripulite le pareti laterali ma la linea è perfetta. Ci prepariamo e via, alle 7.30 si parte!
Dopo un breve saltino di ghiaccio e un piccolo nevaio si diparte la lunghezza più continua e difficile. Ghiaccio sottile e croste vuote poco proteggibili, ma per fortuna sulla destra ci si può aiutare di tanto in tanto con una “pruetta” rocciosa che consente anche il posizionamento di qualche friend. Dopo 20 metri la linea si chiude leggermente a goulotte e la qualità del ghiaccio migliora un poco. Prima di una strettoia verticale si appoggia leggermente e presenta un blocco che consente una sosta a friend. Il primo tiro difficile è andato!
 Sul primo tiro chiave - Ph Arch A. Giolitti
Sul primo tiro chiave - Ph Arch A. Giolitti
 Sul primo tiro vista dall'alto - Ph Arch M. Tomatis
Sul primo tiro vista dall'alto - Ph Arch M. Tomatis
 Partenza del terzo tiro - Ph Arch A. Giolitti
Partenza del terzo tiro - Ph Arch A. Giolitti
 Appena sotto la S4 vicino al fungo di neve - Ph Arch A. Giolitti
Appena sotto la S4 vicino al fungo di neve - Ph Arch A. Giolitti
 Partenza del quinto tiro - Ph Arch A. Giolitti
Partenza del quinto tiro - Ph Arch A. Giolitti
 Partenza del sesto tiro in uscita dal grottino - Ph Arch M. Tomatis
Partenza del sesto tiro in uscita dal grottino - Ph Arch M. Tomatis
 Uscita dall'ultima bellissima lunghezza - Ph Arch A. Giolitti
Uscita dall'ultima bellissima lunghezza - Ph Arch A. Giolitti
Segue un tiro più facile con una strettoia verticale su ghiaccio misto a neve poco compatta, breve goulotte e poi nevaio. Poi ancora un altro tiro impegnativo.
La goulotte superiore precipita su uno scivolo roccioso in ghiaccio sottilissimo e neve riportata. Michele, con molta perizia, lo risale aiutandosi con la roccia sulla destra, sia con agganci di picca che appoggi di piede, per poi prendere l’uscita in ghiaccio sottile e infilarsi nella goulotte con un passo delicato. La parte successiva dovrebbe presentare ancora una goulotte, ma, in realtà, ci offre di nuovo una sorpresa: altro scenario simile a quello appena descritto, dove, per evitare uno scivolo di ghiaccio eccessivamente sottile chiuso da un fungo di neve, mi tocca divincolarmi (più spingere che tirare…) tra neve e roccia di scarsa qualità fino ad arrivarci al di sopra.
Seguono lunghi tratti in goulotte con alcuni risalti di cui i più delicati e ripidi in partenza dalle soste, sempre complicati da scarsa o comunque non buona proteggibilità.
 Sul primo tiro vista dall'alto - Ph Arch M. TomatisLa goulotte finale è la linea di alpin ice perfetta che tutti sognano!
Sul primo tiro vista dall'alto - Ph Arch M. TomatisLa goulotte finale è la linea di alpin ice perfetta che tutti sognano!
Alle 15 raggiungiamo il nevaio che dà accesso alla rampa e, nonostante avessimo valutato anche la possibilità di proseguire oltre, riteniamo che abbia più senso fermarci qua ed attrezzare le soste di calata, rendendo la linea fruibile fine a sé stessa, piuttosto che proseguire su terreno classico che poco avrebbe a che vedere con la parte sottostante.
Il tempo di calarci predisponendo le soste a spit e siamo agli zaini. Ci pervade la soddisfazione di aver colto l’attimo e salito quella che mi sento di definire la più estetica e continua linea di ghiaccio e misto del gruppo del Monviso!
Grande soddisfazione, inoltre, nell’aver coinvolto nell’avventura il giovane Michele Tomatis, conosciuto due anni fa in occasione dell’MCM 2024 (Mixed Climbing Meet) del Club Alpino Accademico nel Mercantour e che ha nuovamente partecipato all’edizione di quest’anno nelle Piccole Dolomiti.
Abbiamo anche avuto già qualche altra occasione di scalare insieme, ma credo che un seme importante lo abbiano gettato i Meeting del CAAI, che hanno proprio l’obiettivo di creare occasioni di scambio, conoscenza e trasmettere un modo di fare alpinismo rivolto principalmente all’avventura e alla ricerca. Michele inoltre ha confermato una volta di più le sue grandi capacità, giocando e gestendo alla pari la salita e dimostrandosi un socio perfetto!!
CRUMBLING EMPIRE è il titolo di una canzone del cantante inglese Sam Fender che esplora la fragilità della società moderna, utilizzando metafore potenti per descrivere un mondo che sembra sull’orlo del collasso. “Crumbling Empire” (letteralmente “Impero che crolla”), suggerisce un senso di decadenza e declino. Riflette sulle difficoltà del presente, sulla tensione tra passato e futuro e sulla ricerca di un senso di stabilità in un’epoca di incertezza che io interpreto ed estendo, in senso più ampio, anche alla decadenza negli atteggiamenti e nell’etica delle persone e alla fragilità delle montagne che affrontano e spesso subiscono il cambiamento climatico con conseguenze anche sulla pratica dell’alpinismo.
 Il Viso Mozzo, posizione privilegiata di osservazione, fotografato da S6 - Ph Arch A. Giolitti
Il Viso Mozzo, posizione privilegiata di osservazione, fotografato da S6 - Ph Arch A. Giolitti Selfie al ritorno a terra - Ph Arch A. Giolitti
Selfie al ritorno a terra - Ph Arch A. Giolitti
SCHEDA TECNICA scarica qui la relazione
CRUMBLING EMPIRE
 MONVISO Colatoio Est-Nord-Est - 300 m ED+ IV/5+ M5
MONVISO Colatoio Est-Nord-Est - 300 m ED+ IV/5+ M5
Prima salita: Anselmo Giolitti e Michele Tomatis il 25 aprile 2025
Avvicinamento: da Crissolo - Pian della Regina, si imbocca il vallone del Rio dei Quarti, in prossimità del Lago Chiaretto si prosegue in direzione del Colle di Viso fino a portarsi sotto l'imponente versante NE del Monviso. Il colatoio di Crumbling Empire è quello immediatamente a sinistra del couloir NE (2,5-3h).
Percorso
L1 . Breve risalto (70°), nevaio, poi lungo nastro ghiacciato in leggero strapiombo (90°) passi di misto; 60 mt; sosta a friend sulla destra;
L2 - Strettoia verticale (85°) breve tratto di goulotte più facile (65°) poi fino in cima al secondo nevaio; 60 mt; sosta a friend in una nicchia;
L3 - Rampa verso sinistra tra roccia e neve/ghiaccio sottile con uscita delicata (M5 e 80°) poi successione di risalti in una bella goulotte (65-75°); 60 mt; sosta a friend sulla destra;
L4 - Breve tratto ghiacciato in goulotte (65°) poi si abbandona la colata che si impenna (troppo sottile) proseguendo sulla destra tra neve e roccia fino a un antro per poi ritornare a sx sopra un fungo di neve a fianco di un muro stalattitico; 35 mt; sosta a chiodi + clessidra di ghiaccio.
L5 - Breve risalto verticale (90°) poi goulotte (65-70°); 25/30 mt; sosta su friend in un grottino sulla destra;
L6 - Uscita dal grottino su ghiaccio sottile verticale (85°) poi magnifica goulotte (65-75°); 60 mt; sosta su friend sulla destra.
Materiale utilizzato: una serie di friend, dai micro al 3BD, un assortimento di chiodi da roccia (lama, universale, a U), per una ripetizione 6 chiodi assortiti potrebbero bastare, 8 viti assortite (di cui diverse da 10 e 13), per una ripetizione 6 potrebbero essere sufficienti.
Discesa: i primi salitori hanno allestito 5 soste a spit per lunghe doppie da 60 m, in cui gestire le corde con perizia (nodo, accavallamenti, ecc.). Sulla via non è rimasto null’altro!
NB: La relazione è fatta sulla base dell’andamento seguito nella prima salita. Le condizioni della linea possono essere molto variabili e quindi potrebbe rendersi necessaria una gestione diversa delle lunghezze ma, nel caso, la maggior parte delle soste allestite coincide o è alla stessa altezza di quelle create da noi in salita.
CHIODO D’ORO EDIZIONE 2025
di Francesco Leardi Presidente CAAI Gruppo Orientale
Sarò un modesto e breve narratore di un bellissimo evento che la SOSAT di Trento porta alla conoscenza del grande mondo alpinistico ormai da vent’anni e che da due anni vede la collaborazione del Club Alpino Accademico Italiano gruppo Orientale per l’analisi delle candidature e la successiva designazione al conferimento del premio.
All’instancabile ed esplosivo presidente della SOSAT Luciano Ferrari va reso l’onore, oltre che della volontà etica nel perseguire il programma, anche della capacità organizzativa.
Ma ciò che mi ha colpito è stato l’entusiasmo con il quale Luciano ha portato avanti il progetto.
Ma veniamo agli eventi e alla loro cronologia.
 Il coro SOSAT alla manifestazione del Chiodo d'oro 2025 - Ph F. Leardi
Il coro SOSAT alla manifestazione del Chiodo d'oro 2025 - Ph F. Leardi
1° Maggio ore 18,30, sotto la sede di Via Malpaga è assiepato gran parte del mondo alpinistico trentino, e non solo, in attesa di salire nella bellissima e storica sala affrescata della SOSAT.
Sulle vie centrali di Trento un brulicare di appassionati di montagna, perché tutto orbita in questi giorni intorno al Trento Film Festival nel quale è inserita la nostra manifestazione del Chiodo d’oro, tassello fondamentale degli eventi.
I titolari del riconoscimento Pierino Radin e Davide Sassudelli parlano tra di loro nella prima fila di sedie della sala, generazioni a confronto si potrebbe dire molto banalmente, ma altrettanto semplicemente, come nell’etica del premio, attori di questo momento che non incorona campioni ma i valori dell’uomo alpinista.
Grandi sorprese mi aveva annunciato Luciano Ferrari in una sua lunga telefonata ricevuta circa un mesetto fa, nella quale aveva parlato ininterrottamente per un bel po’ di minuti, illustrandomi il progetto, perorando il mio contributo. Il mio intervento in questo contesto fu breve e minimalista: ci sarò!
La bravissima e simpatica presentatrice, la giornalista Fausta Slanzi, introduce l’inizio della manifestazione. Un contributo al pianoforte del maestro del Coro della SOSAT Roberto Garniga che fa entrare la sala in sintonia con il profilo etico del Chiodo d’oro.
La parola passa quindi al presidente SOSAT Luciano Ferrari, che, con la sua leggendaria verve, ricorda la struttura organizzativa del progetto e i passaggi svolti per arrivare alla definizione dei due premiati.
Nell’intervento successivo il Presidente del Trento Film Festival Mauro Leveghi mette in evidenza il notevole sviluppo della manifestazione da lui presieduta con i numerosi contributi cinematografici di alto livello, le numerose tavole rotonde e i dibattiti alpinistici sempre alla presenza di un numeroso pubblico assai competente e sempre molto attento.
Tocca quindi al Sindaco di Trento Franco Ianeselli che, da Sosatino, ci fa intendere di avere davanti a noi una persona assai sensibile all’ambito montano.
Nel frattempo arriva in sala il presidente generale del CAI Antonio Montani e, senza false enfatizzazioni, devo ammettere che la manifestazione raggiunge il suo massimo apice di notorietà.
Quindi vengo chiamato dalla moderatrice Fausta a relazionare come presidente del gruppo orientale che, vorrei ricordare, contribuisce alla manifestazione con il “giudizio” sui candidati con la sua Commissione Tecnica, che rimane tale in quanto la decisione finale compete alla commissione SOSAT del Premio Chiodo d’Oro. In questo contesto vorrei ringraziare la mia Commissione Tecnica composta da Ivo Maistrello, Alessio Gualdo, Antonio Zanetti, Mirco Grasso sempre molto collaborativi.
 Luciano Ferrari, Presidente della SOSAT, consegna il Chiodo d'oro 2025 - Ph F. Leardi
Luciano Ferrari, Presidente della SOSAT, consegna il Chiodo d'oro 2025 - Ph F. Leardi
L’intervento di Francesco Leardi all’edizione 2025 del Chiodo d’Oro
Non userò toni di ufficialità che non desidero molto ma semplici parole.
Sempre difficile scegliere tra i valori delle persone e in effetti tutte le figure proposte dai componenti dell’ambizioso progetto Chiodo d’Oro erano meritevoli ma non solo, oserei dire prestigiose e certamente allineate con le filosofie del premio: continuità, versatilità, modestia e capacità comunicativa.
Le personalità chiamate a scegliere inoltre erano e sono assai variegate come carattere, sensibilità ed esperienze alpinistiche diverse.
Non è stato facile per ognuno di noi componenti selezionare - che termine antipatico! - ma al varco ci aspettava una scelta.
Ritengo che le persone premiate, il veterano Pierino e il giovane Davide rappresentino pienamente il senso del progetto anche con il concetto che due opposti si attraggono e, infatti, hanno riscosso la nostra preferenza: il primo era ed è il più anziano ed il secondo ovviamente il più giovane del branco.
Il primo, esponente del mondo alpinistico del Nordest con una storia eccezionale alle spalle e, il secondo, eclettico portatore di capacità, esuberanza e versatilità del panorama trentino e non solo.
 Interviene Mauro Leveghi, Presidente del Trento Film Festival - Ph F. Leardi
Interviene Mauro Leveghi, Presidente del Trento Film Festival - Ph F. Leardi
Ovviamente posso parlare liberamente di Pierino, mio collega del gruppo orientale dell’Accademico che mi offre lo spunto per farmi credere e convincere che chi fa alpinismo, insomma chi arrampica, cammina, frequenta i giovani non invecchia mai.
Sono accademico dal 1993 e ho sempre visto Pierino così, si certo un poco più giovane ma sempre smilzo, con i suoi baffetti risorgimentali, lo sguardo intrigante, il gesticolare delle braccia un poco furioso, gli occhietti sempre così incuriositi e, volendo scherzarci su, almeno per me che non sono veneto di origine ma di adozione, con la necessità di traduzione simultanea dal dialetto veneto all’italiano.
Ma la cosa che mi ha sempre incuriosito è il suo percorso fatto con Renato Casarotto, che amplifica secondo me le qualità di Pierino poiché, per convivere con un personaggio come Casarotto, certamente occorrevano tenacia e capacità fuori dal comune.
Si dice che tutto torna e credo molto in questo.
1980: Spedizione Everest diretta da Francesco Santon con vari esponenti tra i quali De Marchi, Giambisi, Martini, e vari altri.
A Pierino si sgancia un rampone, davanti a lui il bravo e umile alpinista genovese Franco Piana.
Una slavina e Franco sparisce in un crepaccio.
Io vengo dall’ambiente alpinistico genovese e avevo arrampicato molto con Franco, per me un amico, ma, soprattutto, un esempio di umanità e impegno sociale.
Ebbene Pierino mi ha concesso di vivere l’emozione del ricordo con la sua umana dialettica che lascia intendere di un anima piena di ideali e sentimenti.
È un piccolo e breve cameo che mi unisce molto umilmente a Pierino.
 La presentatrice Fausta Slanzi con i premiati Piero Radin e Davide SassudelliE veniamo alla scelta del giovane Davide.
La presentatrice Fausta Slanzi con i premiati Piero Radin e Davide SassudelliE veniamo alla scelta del giovane Davide.
Non lo conosco di persona, ho letto di lui, ho sentito le solite voci di corridoio.
Guida alpina e pilota biposto di parapendio.
Laureato in sociologia e da diversi anni componente del Soccorso alpino Trentino.
26 anni!
Ma in così poco tempo, viene da chiedersi, come ha fatto a fare così tante cose?
Un’altra cosa, ed è brutto dirlo, ma ho un personale atteggiamento di invidia nei suoi confronti.
Il volo, non quello in falesia naturalmente, ma quello in parapendio che non ho mai fatto ma si dice che c’è più tempo che vita.
A tal proposito, e ovviamente bisogna approfittare delle situazioni, ho rivolto la richiesta personale di poter provare a volare con lui.
La mia origine genovese però mi ha imposto di richiedere la prestazione “a gratis”, ma naturalmente questa è un'altra storia!
Dopo il mio intervento è la volta di Renzo Fracalossi e devo spendere due righe sul suo personaggio.
Renzo Fracalossi, è nato a Rovereto il 5 luglio 1961. Risiede a Trento dove, dopo gli studi umanistici, lavora nella pubblica Amministrazione. Presiede l’associazione culturale "Club Armonia"; è componente della "Società di Studi Trentini di Scienze storiche" e della SOSAT Ricercatore e divulgatore, si occupa da decenni di approfondire e narrare l'antisemitismo e con esso la Shoah e di indagare la storia locale. Collabora con università e centri di ricerca europei su tali questioni ed ha all'attivo alcune pubblicazioni e contributi. È autore teatrale, iscritto alla SIAE, con testi rappresentati in sede locale e nazionale.
Gentilmente mi ha fornito i suoi contributi, che, se da un punto letterario sono stupendi, purtroppo sono privi della enfasi teatrale con la quale Renzo ha raccontato di Pierino e Davide.
Provate comunque a leggere e riflettere perché non è solo prosa ma poesia ed amore per gli uomini e la montagna.
Piero Radin, passione indomabile
di Renzo Fracalossi
 Piero Radin - Ph Arch. SOSATDentro il verde colore di occhi vivacissimi; dietro un sorriso di eterno ragazzo ed un corpo esile che sprizza forza e volontà, si celano ottantadue anni di simpatia senza confini e di una modestia che è lezione prima degli uomini grandi.
Piero Radin - Ph Arch. SOSATDentro il verde colore di occhi vivacissimi; dietro un sorriso di eterno ragazzo ed un corpo esile che sprizza forza e volontà, si celano ottantadue anni di simpatia senza confini e di una modestia che è lezione prima degli uomini grandi.
Eppure quel viso buono e carico di dolcezza ricorda un altro volto. Lo vedo, nella penombra del tempo, ma non riesco a metterne a fuoco il profilo e l’immagine. Eppure...
1974. Lui ha trentun anni. Prima di fare lo Spigolo Strobel, Renato Casarotto mette alla prova due ragazzi, gonfi solo della loro passione pura.
Uno è Diego Campi. L’altro è lui e la sfida è lo Spigolo Boschetti – Zaltron, con la variante Timillero, sulla sud-est del Soglio d’Uderle, nelle geografie del Pasubio in Vallarsa.
Eppure quel volto... Non riesco a smettere di frugare nella memoria, senza però che venga a galla alcunché. Le movenze, lo spirito, la passione sembrano quelli, eppure non sono capace di far brillare in me il ricordo.
Quello Spigolo prevede un tetto da passare con le staffe. Lui è l’ultimo a salire e, proprio in quel tratto, perde la staffa. Casarotto gli dice che l’unica soluzione è salire con il “nodo Prusik”. Lui fa un pendolo che adesso, cinquant’anni dopo, rammenta ancora perfettamente. Dopo un’esperienza così, non arrampichi più o vai su, fino oltre gli ottant’anni.
Lui, ovviamente, sceglie di continuare. Non è arroganza inutile. Non è brivido adrenalinico fine a se stesso: Non è bisogno narcisistico di esibirsi. È solo passione. Grande. Autentica. Forte e potente, come gli amori veri. È esplorazione. È dialogo con l’incognito. È solitudine che diventa bellezza. È l’avventura pulita di salire sapendo solo dov’è l’attacco della via e null’altro. In un nome è: Piero Radin, “mato par le crode”.
Ma quella faccia asciutta e fiera continua a girare fra gli anfratti della mia mente. Stimola lo scavo dentro il tempo andato. Chiama all’appello delle rimembranze. Ma, niente. Non ci riesco...
Piero è un alpinista d’altri tempi, un solitario che non ama essere “inquadrato”, perché sa che, quando tutto è sicuro, perfetto, programmato e con un prezzo, l’alpinismo puro evapora e non rimane nulla. Solo tecnica che uccide l’anima.
Prima della spedizione sull’Annapurna, sale per la via Vinatzer in Marmolada. È il 1977 e lui è solo con la montagna. La sera si trova ad un tiro di corda dalla cengia, ma non conosce la via e decide di bivaccare in una piccola grotta. Una notte illuminata di stelle rarefatte che mette i brividi. Lui, la notte e la parete di roccia che parla e dice di sensazioni uniche ed irripetibili. Ci vuole “voglia di andare “, per fare certe vie, come quelle che Piero Radin ha fatto da solo e con Renato Casarotto.
Poi l’Annapurna. Un crepaccio dietro l’altro. Dall’ultimo Campo, ancora un canalone, una cresta e poi la vetta. Piero va su con Giorgio. Giorgio Brianzi.
La difficoltà maggiore è sempre scendere. La pendenza è di circa 60 gradi.
Nella discesa Giorgio scivola e trascina con sé Piero. Volano, prima di ritrovarsi appesi all’unico chiodo che Piero aveva piantato. Una gamba rotta e l’immensa fatica a muoversi, finché li vedono e li calano in doppia prima che arrivi la notte.
Una mano è bianca. Di un candore irreale. Non sente più le dita. Anche la gamba non la sente quasi più. Per arrivare al Campo base, in quelle condizioni, ci vogliono sette giorni.
Tornato a Vicenza Piero va in ospedale. Le prime falangi sono nere. I medici gli dicono che può dire addio all’arrampicata. Ma cosa ne sanno loro? Con tre falangi in meno e qualche difficoltà in più , Piero Radin continua a salire.
Lo fa ancora oggi. Ad ottantadue anni.
Piero ha iniziato a ventotto anni e fra i suoi traguardi campeggia la spedizione sull’Huandoy Sud in Perù ; sull’Annapurna nel Nepal centrale; il Diedro Casarotto – Radin sulle Pale di San Lucano; lo Spigolo Strobel nelle Dolomiti di Zoldo in invernale, ma anche la vetta dello Shivling in Himalaya e centinaia di altre vie che gli conferiscono il prestigioso titolo di Accademico del CAI e lo accompagnano in ogni alba che lo illumina e lo spinge avanti sul sentiero della vita.
Nel 1996, Piero è capocorda con il suo compagno di sempre Giacomo Albiero, sulla Solleder-Lettenbauer, uno dei più classici sesto grado delle Dolomiti.
Giacomo ha settantun anni e Piero cinquantatré, senza le punte delle dita della mano destra.
Lo osservo intensamente e finalmente ricordo. Piero è l’immagine speculare di Primo. Primo Levi. Di lui conosciamo la profondità del legame con la sofferenza infinita, ma anche con la montagna e mentre li guardo entrambi: un volto incorniciato dalla barba a pizzo che parla di asprezze e l’altro con quei baffi che dilatano il sorriso, ripenso al senso di totalità che la montagna offre a chi, come loro, la sa cogliere. Due uomini che portano nello zaino mille storie. Le loro e le nostre, a dire della montagna che accomuna ed insegna; che consola ed affascina, che rende vivi anche quando la vita se ne è andata; che ascolta la nostra stolta frenesia e ci offre ritmi più lenti e veri. La montagna è spontaneità, non è esibizione. Ecco perché: Piero Radin ne è degno figlio ed altri, molti altri, nemmeno si avvicinano a questa gran madre che custodisce il misterioso segreto dell’avventura umana.
Davide che vola sulle montagne
di Renzo Fracalossi
Nel mito greco, Dedalo viene imprigionato nel suo stesso labirinto, dal quale fugge, costruendo per sé e per il figlio Icaro, ali di penne e cera. Si alzano in volo verso la Sicilia e, mentre Icaro si avvicina troppo al sole che cola la cera delle ali e lo fa precipitare, Dedalo si salva. Giunto nella Magna Grecia costruisce un po’ ovunque templi al dio Febo Apollo.
Arrampicare e volare sono le vie della libertà.
Infatti, se volare significa creare nuove strade oltre i limiti tra desiderio e possibilità, arrampicare vuol dire cercare il giusto equilibrio fra coraggio e passione; infrangere il vento ed abbracciare i raggi del sole; estendere il respiro all’infinito, guardando la vita in modo diverso e sempre nuovo.
“Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza.
Li miei compagni fec’io sì aguti
con questa orazione picciola, al cammino,
che a pena poscia li avrei ritenuti
e volta nostra poppa al mattino
de’ remi facemmo ali al folle volo,
sempre acquistando dal lato mancino”
(Divina Commedia – Inferno – Canto XXVI - 100/142)
 Davide Sassudelli - Ph Arch. SOSATÈ nel folle volo di Ulisse che si raccoglie la giovane, quanto totalizzante, esperienza dei ventisei anni Davide Sassudelli, che inizia a scalare per gli occhi e i baci di una ragazza e da lì prende il volo verso l’infinito azzurro che tutto contiene. Uomo di montagna e di cieli nasce in una “nave” - Nave San Rocco - quasi a voler contenere nel sogno e nella sua storia di individuo tutto l’immensità della natura madre. Sociologo e Guida Alpina: una scelta di studi che prova a penetrare il sociale ed un richiamo irresistibile della vita verso la sfida, la prova, la misurazione di sè stessi e dell’immenso.
Davide Sassudelli - Ph Arch. SOSATÈ nel folle volo di Ulisse che si raccoglie la giovane, quanto totalizzante, esperienza dei ventisei anni Davide Sassudelli, che inizia a scalare per gli occhi e i baci di una ragazza e da lì prende il volo verso l’infinito azzurro che tutto contiene. Uomo di montagna e di cieli nasce in una “nave” - Nave San Rocco - quasi a voler contenere nel sogno e nella sua storia di individuo tutto l’immensità della natura madre. Sociologo e Guida Alpina: una scelta di studi che prova a penetrare il sociale ed un richiamo irresistibile della vita verso la sfida, la prova, la misurazione di sè stessi e dell’immenso.
È davanti a tutto questo che l’uomo si avverte “nudo”, piccolo soffio di divino impastato con la terra. E così Davide onora l’antica origine ebraica del suo nome, affrontando quel gigante Golia di pietra che è la montagna.
Lo fa con la leggerezza della gioventù e la consapevolezza responsabile dell’esperto, ponendosi limiti, ma anche ampliando orizzonti alla ricerca di una libertà esteriore che è riflesso di quella interiore.
Proprio in quella ricerca, così cara alla cultura più vera dell’alpinismo, Davide, come Dedalo, vuole fuggire dal labirinto del quotidiano volando e si costruisce le ali, frequentando quei corsi di parapendio che gli permettono di librarsi nel vuoto silente e pieno di magia. Sale sul Campanil Basso, insieme ai suoi amici Matteo Pavana e Stefano Piatti, dalla via Preuss. Nello zaino non c’è quasi nulla del montanaro. Tutto lo spazio è occupato dal parapendio. Salendo quella via, aperta in due ore e senza alcun ausilio il 28 luglio 1911 da un purista assoluto della scalata come Paul Preuss, anch’egli di radice ebraica a testimoniare il legame dei popoli del Libro con la montagna, Davide sente dilatarsi dentro di sè il sogno umano di sempre, quello cioè di volare e di essere padroni dell’aria.
Dal “Basso”, questo ragazzo, entusiasta della vita e rapito dalla bellezza più sublime, si lancia per il primo volo umano dal Campanile più famoso delle Dolomiti che, ammirato da tanto ardimento, risuona di silenti rintocchi naturali che si spalmano sull’orizzonte.
Guardare dall’alto le montagne che si stendono in un tappeto di vette e nubi, di colori e purezza, di esplorazione e sensazioni impagabili, consente diventa essenza del vivere e coscienza di nuove dimensioni dell’umano e delle sue possibilità.
E mentre Davide si lancia da Costalta per giungere in volo a Lienz, in Austria, divorando le Alpi in un solo sguardo di vento, Dedalo segue con passione ed affetto quel suo emulo alpino, stringendo così quel legame fra mito e realtà che la montagna sa custodire fin dalla creazione di Genesi.
Ascendere il cielo, ma non staccarsi dalla terra. È questo il mistero che anima Davide che adesso vuol partire da casa volando, per giungere in Marmolada e scalare la “via del pesce”, per poi riprendere le ali che lo porteranno sulle rotte del ritorno.
“Or ti piaccia gradir la sua venuta:
libertà va cercando, ch’è sì cara,
come sa chi per lei vita rifiuta.”
(Divina Commedia – Purgatorio – Canto I – 70/72).
Non servirà arrivare a tanto, ma quella libertà abita Davide e lo rende ciò che è: un giovane uomo libero e coraggioso, che esplora l’universo, sapendo d’esserne frammento infinitesimale e, al contempo, centro e motore di ogni nuovo traguardo. Minuscolo atomo appiccicato alla roccia, che sfida ogni legge e perfino quelle dell’Infinito, alzandosi poi verso il sole per dire delle possibilità immense dell’uomo.
Montagna e cielo, per esistere e resistere. Questo è Davide Sassudelli.
Due brevi filmati molto coinvolgenti accompagnano la presentazione ufficiale di Pierino e Davide.
 Entrano materialmente così in gioco i due premiati.
Entrano materialmente così in gioco i due premiati.
Dapprima un emozionato e commosso Pierino Radin che scuote l’assemblea con la simpatica frase “Mi parlo solo dialetto” supportato da una divertita Fausta che abbandona l’ufficialità chiedendo dolcemente il senso dell’andare in montagna per Pierino.
Molto semplicemente per il piacere, per la bellezza, per il divertimento!
Non potevano esprimere meglio queste parole la figura di un uomo dagli occhi così vivi e ricchi di umanità.
Davide ci ha offerto l’immagine di un ragazzo alla ricerca della libertà, concetto assai complesso e aleatorio per carità, e di quella sensazione che il volo può dare tra l’altro combinato con l’arrampicata.
Arrampicare, volare, guardare mondo e società da prospettive che non tutti possiamo permetterci, almeno abbinate tra loro.
Uno sguardo limpido, semplice, insomma un esempio per la sua generazione. E la nostra!
La premiazione ha poi completato la parte ufficiale del percorso della manifestazione su un palco di tutto rispetto che oltre ai due premiati era composto dal presidente della SOSAT Luciano Ferrari, il sindaco di Trento Franco Ianeselli, il presidente del Trento film Festival Mauro Leveghi e il presidente del C.A.I. Antonio Montani.
Un parterre d’eccezione per due splendide persone.
Grazie alla ottima acustica della sala dell’evento abbiamo poi potuto apprezzare come suggello finale il coro della SOSAT che si è esibito in strada per il piacere non solo nostro, che lo ascoltavamo dalle finestre aperte, ma dei numerosi passanti diventati pubblico per un evento che non scorderò.
Al 2026 allora, e certamente il buon Luciano Ferrari ci stupirà ancora con i suoi effetti speciali!
Un momento di ricordo particolare della SOSAT è stato dedicato a un loro socio molto amato non più materialmente tra noi. Un intimo abbraccio della sala ha stretto la moglie e la figlia presenti in sala.
Ciao Claudio!
Tra le varie iniziative promosse dal Club Alpino Accademico Italiano nel 2025, il Gruppo Orientale organizza un meeting alpinistico in Valle del Sarca riservato a giovani alpinisti.
L’evento si svolgerà nei giorni 16/17/18 maggio e si chiamerà SARCA CLIMBING MEET 2025.
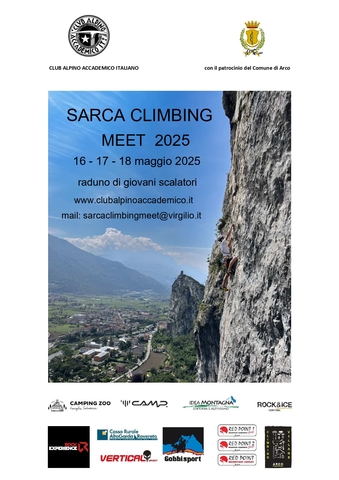
Parteciperanno oltre 50 giovani alpinisti di età compresa tra i 18 e i 30 anni, provenienti da tutta Italia e selezionati in collaborazione con le Scuole di Alpinismo del CAI.
L’evento prevede:
- 2 serate a contenuto tecnico, culturale, filosofico e storico:
venerdì 15 Arrampicarsi nella Valle del Sarca di Giampaolo Calzà "Trota"
sabato 16 Il richiamo dell'ignoto di Maurizio Giordani
- 2 giornate di attività arrampicatoria libera (sabato 16 e domenica 17 maggio)
- Un evento finale di chiusura (domenica 18 maggio)
LA GROTTA DEL’EDERA
Da "tempio sacro" del finalese a parco giochi esclusivo - alcune considerazioni sul Red Bull Ivy
Foto tratte dai siti web che hanno pubblicizzato l'evento - Foto di copertina Courtesy MUDIF - Museo Diffuso del Finale
Il 3 aprile la Grotta dell'edera ha ospitato un evento commerciale che l'ha trasformata per un giorno. Da iconico luogo per camminatori e arrampicatori in cerca di meraviglia a guazzabuglio di lucine colorate, musica e elicotteri per il trasporto dei materiali.

Di cosa si è trattato
Red Bull Ivy, la competizione di arrampicata unica nel suo genere, arriva a Finale Ligure!
Dodici squadre, composte da due persone ciascuna, si sfideranno sulle pareti dell'iconica Grotta dell'Edera in una gara d'arrampicata caratterizzata da un format senza precedenti che premierà abilità, talento, rapidità e... gioco di squadra.
Ciascun team dovrà infatti arrampicarsi sulle pareti seguendo due percorsi di diversa difficoltà: uno dei componenti della squadra salirà lungo quello facile, mentre l'altro avrà il compito di arrampicarsi lungo quello più difficile. Ogni team dovrà impiegare il minor tempo possibile per raggiungere la cima della parete, ma il cronometro non sarà il loro unico avversario dato che le squadre se la vedranno con... dei fasci di luce mobili!
I climber alle prese con il percorso difficile dovranno infatti cercare di sfuggire alle luci per evitare l'eliminazione, e per farlo potranno contare sul supporto dei loro compagni di squadra: i climber che affronteranno il percorso facile, infatti, dovranno cercare di spegnere gli interruttori dei fari e permettere così ai loro partner di raggiungere la fine del percorso.
Tra coloro che non saranno stati eliminati dalla luce, i più rapidi saranno incoronati vincitori di Red Bull Ivy!
(Fonte: Sito Red Bull)
“L’impronta lasciata da Red Bull Ivy è destinata a durare nel tempo – ha commentato Simona Ferro, assessore allo Sport della Regione Liguria – È stato un evento che ha saputo esaltare la bellezza del nostro territorio e consolidare Finale Ligure come punto di riferimento internazionale per l’arrampicata outdoor. In questo anno in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport, abbiamo celebrato l’arrampicata non solo come disciplina avvincente, ma come stile di vita sano, sostenibile e a contatto con la natura.”
(Fonte: Sito Sport24h)
(filmato youtube)
 Scrive una riflessione in merito sui suoi canali social Gabriele Canu, filmmaker e Accademico del Gruppo Occidentale:
Scrive una riflessione in merito sui suoi canali social Gabriele Canu, filmmaker e Accademico del Gruppo Occidentale:
Diverse persone, in questi giorni, mi hanno chiesto se non ho niente da dire in merito a questo evento. Certo che ce l’ho, ma ho anche una vita, e soprattutto non credo che a Red Bull possa fregare di meno di chi la pensa diversamente. Tuttavia, visto che pare che quelli poco felici di questo evento non siano solo tre ma la cosa sembra essere passata in un curioso quando assordante silenzio, mi prendo la briga di dire quello che penso. È abbastanza chiaro perché nessuno si sia esposto: troppi interessi in gioco, possibili clienti futuri, colleghi, amici o pseudo tali che hanno partecipato o supportato in un modo o nell’altro l’evento più cool dell’anno. Si aspetta sempre sia qualcun altro a esporsi, perché inimicarsi la gente non fa mai piacere. È più facile indignarsi per cose lontane, dove non si conosce nessuno e dunque non si rischia nulla: l’indignazione in un raggio di trenta chilometri da casa è uno sport estremo, altro che la scalata.
Ma con chi ce la si può prendere per la realizzazione di questo “evento intimo, rispettoso e potente” (cit. dal sito)? Con Redbull? Se a un’azienda il cui unico interesse oltre al fatturato è la spettacolarizzazione di qualsiasi cosa gli critichi la spettacolarizzazione, cosa vuoi che ti rispondano? È il loro core business. Più che guardarti con un enorme punto interrogativo stampato in faccia non possono fare.
Poi a me viene da chiedere: cosa c’è da spettacolarizzare alla grotta dell’edera, che non abbia già fatto madre natura a costo zero? Non ci accontentiamo, MAI. Chi si accontenta è un perdente, bisogna sempre spingersi un po’ più in là. D’altra parte parliamo di un luogo, la grotta dell’edera, che ha un nome che non la rispecchia più da quando dei disgraziati (non saprei trovare un altro termine, se qualcuno ha un suggerimento politically correct sono tutt’orecchi), per due tiri da scalare in più, hanno tolto le ultime tracce di rampicante rimaste. Sono ormai passati un po' di anni: eravamo dei trogloditi egoisti, e nella migliore delle ipotesi non siamo migliorati.
Ormai il messaggio evidente che passa è che questo sia il modello turistico giusto, che questo sensazionalismo illuminato da lucine colorate e sfavillanti, generatori e musica ad alto impatto cerebrale in mezzo ai boschi finalesi sia normale. È normale che ci gasiamo per le lucine, è normale che ci gasiamo dicendo che poi tutto è stato ripulito (siamo arrivati al punto che chi ripulisce ciò che lui stesso ha sporcato assurge quasi il ruolo di benefattore), ma poi facciamo finta di nulla sull'etica dietro a un evento così. Ma ci siamo divertiti, si sono divertiti, c’è chi s’è divertito…quindi va tutto bene, chi se ne frega dell'etica. Un luna park nella natura a cui mancavano solo i tornelli, lo zucchero filante e tanto, tanto buongusto. Saran stati sicuramente contenti gli animali che lì ci vivono tutti i giorni, sarebbe opportuno fare una serie di interviste.
Ma l’amministrazione in tutto ciò cosa dice? Va tutto bene? È un evento di promozione del territorio? È Redbull, quindi visibilità, quindi tutto buono? Sembra di sì, leggo “fattiva collaborazione e disponibilità del Comune di Finale Ligure”. Evidentemente gli è piaciuto e gli è sembrato un bel modo di promuovere il paradiso finalese.
È un evento, è una sera? Si, ogni cosa inizia così. Se fai passare il messaggio che la grotta dell'edera è un circo, i mesi, gli anni e il tempo lo trasformeranno nel circo. Non è una novità, è così dalla notte dei tempi. C'è sempre un inizio.
Non è vietato? No, non è vietato, purtroppo: dunque rimane una questione di sensibilità. E come tale, soggetta ad interpretazioni e strumentalizzazioni in base ai propri interessi.
Nessuno che riesca a cogliere la logica del profitto che c'è dietro questa "experience" di Redbull? Si prende un luogo iconico e unico del finalese e lo si trasforma in una location pubblicitaria per una ditta privata, con un evento privato e ad invito per rendere la cosa più "in". Questa storia puzza di elitarismo e consumismo come le mie narici non respiravano da tempo.
La mia sensibilità mi dice che il punto non è Red Bull, è chi in queste schifezze ci crede. Il punto è chi fissando le lucine si diventa ciechi sul fatto che questa cosa ha un costo. Non monetario: per quello lo sappiamo bene che quando andiamo a cena e offre qualcun altro cerchiamo i piatti che costano di più anche se non ci piacciono, e qui non eravamo noi a pagare.
Ma ambientale. Etico. Di rispetto nei confronti della natura, che da coprotagonista di una storia diventa mezzo di spettacolarizzazione: non l'uomo come parte viscerale di un ambiente, ma un ambiente al servizio dello spettacolo.
Trump dall’altra parte del mondo mira a distruggere ecosistemi, qui tutti critici e a pubblicare meme, a sdegnarsi, a prendere le distanze, a dire che si è fatti di ben altra pasta, ma quando si tratta di preservare il proprio territorio che tanto si dichiara di amare - con tanto di continui post romantici e lacrime strappastorie - non ci facciamo poi troppi scrupoli.
Quanta maledetta ipocrisia.
L’evento su INSTAGRAM
e sulla pagina LA MIA LIGURIA/Regione Liguria official account for tourism
L'evento sulle testate web
Sulla pagina ufficiale facebook della Regione Liguria
Ne parla anche IL DOLOMITI, con un’analisi che fa riflettere
Undici nuove vie e alcune ripetizioni storiche: questo il bottino della spedizione in Oman del gruppo composto dai sei ragazzi del CAI Eagle Team Erica Bonalda, Marco Cocito, Daniele Lo Russo, Matteo Monfrini, Lorenzo Toscani e Riccardo Volpiano.
A breve, in una prossima puntata, pubblicheremo le schede tecniche con relazioni e tracciati delle 11 nuove vie aperte: sicuramente una proposta originale e stimolante per i nostri lettori.
L’avventura è stata coordinata dal Club Alpino Accademico Italiano e finanziata dal Club Alpino Italiano. Insieme a loro, tre tutor del CAAI, Marco Ghisio, Mauro Florit e Francesco Leardi.
Nel seguito riportiamo la relazione dettagliata del viaggio, redatta dal coordinatore Marco Ghisio, accompagnata dai ricordi e riflessioni personali dei membri della spedizione.
Ottimizzazione e grafica A. Rampini
 Oman 2025- Relazione generale della spedizione
Oman 2025- Relazione generale della spedizione
di Marco Ghisio
La spedizione in Oman ha rappresentato la naturale conclusione di un progetto incentrato sulle giovani promesse del mondo dell’alpinismo e arrampicata. Giovani che finalmente hanno potuto godere dei frutti delle varie settimane di formazione e mettere in pratica quanto appreso, in un luogo opportunamente scelto non solo per collaborare allo sviluppo turistico e sportivo del territorio omanita ma anche per la quantità e qualità di pareti rocciose a disposizione ancora da esplorare. È grazie a questi due aspetti fondamentali, uniti alla voglia di fare gruppo che i ragazzi hanno messo in atto, che la spedizione può vantare gli ottimi risultati raggiunti.
In particolare, sto parlando delle 11 vie aperte, dove risulta evidente che tutti i partecipanti hanno avuto modo di apporre la propria firma su un nuovo itinerario. Qualcuno già esperto, qualcuno alle prime armi, ognuno ha trovato il giusto terreno per scatenare la fantasia e la voglia di ingaggio.
Le Al Hamra Towers
I primi giorni della spedizione hanno dato un po’ di filo da torcere, prima di tutto per un problema con il rental car che avrebbe fortemente limitato l’esito del tour. Avevamo infatti prenotato 3 jeep e ci hanno consegnato tre berlina, dettaglio non trascurabile considerando che buona parte delle strade secondarie sono sterrate e alcuni accessi alle pareti anche molto sconnessi e ripidi, senza contare la quantità di materiale e viveri che dovevamo trasportare, difficilmente stipabile nelle utilitarie.
 Vista su Al HamraQuesto ci ha costretti a scartare la prima meta, il Wadi Bani AWF, per un’area più a portata di mano come le pareti intorno ad Al Hamra in attesa che si risolvesse il disguido.
Vista su Al HamraQuesto ci ha costretti a scartare la prima meta, il Wadi Bani AWF, per un’area più a portata di mano come le pareti intorno ad Al Hamra in attesa che si risolvesse il disguido.
Così, il primo giorno ci dirigiamo verso le Al Hamra Towers. Le cordate: Mauro e Francesco, Riccardo e Marco Cocito, Erica e Daniele verso la Torre est, Parete nord, in quanto Mauro, in una precedente esplorazione nel 2018, aveva adocchiato alcune linee interessanti e non ancora salite. Ecco, quindi che nascono Evening coffee e Old style. Io, Matteo e Lorenzo ci dirigiamo invece verso la Torre centrale dove, parimenti, avevamo intravisto una possibilità di nuova linea, ma nel nostro caso, dopo i primi tiri ci accorgiamo ben presto che era già stata salita, anche se non presente tra le nostre informazioni, per cui decidiamo di deviare sulla linea di Balha coi Lupi, aperta nel 2017 da Lamantia, Sanguineti ecc. in realtà, nella parte alta, apportiamo una variante di uscita.
In questi primi due giorni non sono mancanti i primi contatti con la popolazione locale, la prima sera sono venuti a trovarci al nostro accampamento un gruppo di ragazzi incuriositi che ci hanno accolto con datteri e termos di caffè aromatizzato, mentre, il giorno seguente, alla base della parete è arrivato un pastore che ci ha poi accompagnato al suo “rifugio” anch’esso offrendoci caffè e datteri. Ci ha poi fatto conoscere i suoi figli, nipoti, cugini e ci stava organizzando una grigliata per la sera successiva.
La diversità culturale e la diffidenza verso questi paesi mediorientali che noi occidentali ci portiamo dietro sicuramente ci limita fortemente in queste occasioni, soprattutto al primo impatto, ma bastano pochi minuti e si comprende chiaramente che gli intenti (almeno qui in Oman per i contatti che abbiamo avuto) sono assolutamente piacevoli e ispirati a un grande senso di ospitalità misto a curiosità.
Alla scoperta del Jabal Misfat al Abriyeen
 Lorenzo sullo sfondo del Jabel Misht
Lorenzo sullo sfondo del Jabel Misht
 "Old Style" alla Al Hamra Tower, una delle vie aperte
"Old Style" alla Al Hamra Tower, una delle vie aperte
Il terzo giorno di spedizione noi tre tutor avevamo fissato l’appuntamento per la sostituzione delle agognate auto e, mentre i ragazzi erano a intenti a ripetere la via Bahla coi lupi, in attesa dell’orario dell’incontro siamo andati in esplorazione al Jabal Misfat al Abriyeen, un bellissimo villaggio, immerso in un oasi verde piena di terrazzamenti, palme e canalizzazioni per l’acqua, da cui parte chiaramente un wadi dalle pareti interessanti e molto poco valorizzate.
Il giorno successivo, pertanto, decidiamo di recarci qui alla ricerca di nuove linee, lo spazio non manca, ci dividiamo in cordate e partiamo. Purtroppo, subito sul primo tiro Marco Cocito tira un pilastrino all’apparenza solido, ma che rapidamente si frattura. Risultato: caduta, ferita alla gamba, ospedale.
Ognuno scende dai propri obiettivi e ci concentriamo nell’aiutare Marco a tornare alla macchina e nell’accompagnarlo in ospedale, dove sarà curato in modo eccezionale, ma questo infortunio lo costringe ai box per 4 giorni, in attesa di riacquistare un po’ di mobilità e far guarire la ferita.
Il giorno dopo torniamo a concludere i nostri progetti e nascono Habibi ad opera di Mauro e Francesco, Feel free to create ad opera di Riccardo ed Erica, quest’ultima alla sua prima esperienza di apertura e la via Sciugomano, completamento dell’avvio di Marco, per mano di Lorenzo e Matteo che supera l’evidente pancia sopra la cengia.
Io e Daniele purtroppo non riusciamo nell’intento e siamo costretti ad abbandonare la nostra via causa roccia scadente, impareremo il mood della spedizione: evitare le zone di roccia gialla anche se esteticamente interessanti!
Sulle spettacolari pareti del Jabel Kawr
Complessivamente in questi primi giorni la roccia non convince, c’è un po’ di scetticismo nel gruppo e forse un pizzico di delusione iniziale, per cui decidiamo di spostarci verso l’area che fin da casa sembrava riservare il più alto potenziale, lo Jabel Kawr e lo Jabel Misht. Soprattutto su quest’ultimo riponevamo grandi aspettative in quanto eravamo interessati ad una via del grande Auer, ma da subito abbiamo capito che non sarebbe stato possibile ripeterla. La parete, alta 1000 m prende sole dalle 7 alle 18 e di giorno si arrivava a oltre 30 gradi, una combinazione improponibile viste anche le difficoltà della via.
 Daniele su Balha coi lupi
Daniele su Balha coi lupi
 Il profilo del French Pillar al Jebel Misht
Il profilo del French Pillar al Jebel Misht
Nell’area del Jabel Kawr sapevamo che le pareti del Said Wall e dell’Al Kumeira wall sarebbero state una valida alternativa: nord pieno e vie di 500 metri, molto frequentate negli anni da Simon Messner e dove è presente anche Vacanze (R)omane, una via di Matteo Della Bordella e Simone Pedeferri.
Per raggiungere l’area sottostante le pareti ci attendono 40 minuti di sterrato di montagna. Arriviamo quindi nel “villaggio” di Al Kumeira, ormai disabitato, ma dove è presente una moschea immersa in una piccola oasi. È proprio qui che noi ci siamo piazzati per i giorni a venire, quelle palme e la canalizzazione di acqua, sono state la nostra salvezza in un ambiente totalmente arido e assolato.
 Campo base ad Al Kumeira
Campo base ad Al Kumeira
 Mauro su "Dreaming the tower"
Mauro su "Dreaming the tower"
 Riccardo a GorgetteSiamo al 25 febbraio, installiamo un nuovo campo base ed effettuiamo giro esplorativo verso le pareti per studiare obbiettivi e avvicinamento e poi definire le cordate per l’indomani. C’è qualche momento di tensione per via degli obiettivi discordanti ma poi, con la pazienza di tutti, troviamo la quadra e si parte. Per me, Matteo e Lorenzo destinazione Vacanze (R)omane, abbiamo voglia di scontrarci con un po’ di alta difficoltà. Erica e Daniele si dirigono su Ticket to the Moon proprio una delle vie di Messner. Riccardo e Mauro, eterni esploratori, si dirigono verso uno sperone al Said Wall, per aprire una nuova via e creano Dreaming the tower. Marco, ancora fermo per via della ferita, e Francesco si prendono la giornata per un giro turistico ma ci fanno un regalo enorme, organizzano una cena coi fiocchi, molto apprezzata da noi famelici arrampicatori. Qui gli avvicinamenti e le discese sono assai più lunghi rispetto ad Al Hamra e le giornate si fanno impegnative.
Riccardo a GorgetteSiamo al 25 febbraio, installiamo un nuovo campo base ed effettuiamo giro esplorativo verso le pareti per studiare obbiettivi e avvicinamento e poi definire le cordate per l’indomani. C’è qualche momento di tensione per via degli obiettivi discordanti ma poi, con la pazienza di tutti, troviamo la quadra e si parte. Per me, Matteo e Lorenzo destinazione Vacanze (R)omane, abbiamo voglia di scontrarci con un po’ di alta difficoltà. Erica e Daniele si dirigono su Ticket to the Moon proprio una delle vie di Messner. Riccardo e Mauro, eterni esploratori, si dirigono verso uno sperone al Said Wall, per aprire una nuova via e creano Dreaming the tower. Marco, ancora fermo per via della ferita, e Francesco si prendono la giornata per un giro turistico ma ci fanno un regalo enorme, organizzano una cena coi fiocchi, molto apprezzata da noi famelici arrampicatori. Qui gli avvicinamenti e le discese sono assai più lunghi rispetto ad Al Hamra e le giornate si fanno impegnative.
26 febbraio rest day. Ci dirigiamo al Wadi Damm perché ci hanno parlato di alcune pozze dove poterci rilassare. Ma Matteo aveva in testa una nuova linea su quel mare di calcare e insieme al nostro King Riccardo, che aveva sentito odore di avventura, prima di concedersi il riposo fanno un altro giro di esplorazione per studiare meglio la possibile linea. Anche chi si rilassa al Damm è sempre con un occhio vigile e intravede una parete sopra al wadi non presente sulla guida e in nessuna cronaca.
I piani per l’indomani sono presto fatti, ognuno di noi ha puntato nuove linee: io, Matteo e Riccardo partiamo per la linea studiata nei giorni precedenti, su una parete di cui non sappiamo neanche il nome, che rimane proprio al centro tra le due note Said e Al Kumeira Wal, con il materiale da bivacco e la determinazione di portarla a casa. Daniele ed Erica si dirigono anche loro su una linea intravista molto a destra su Al Kumeira Wall, che li obbliga a dare il tutto e per tutto, toccando i propri limiti su terreno nuovo, ma purtroppo sono costretti a scendere. Sono comunque stati molto contenti dell’esperienza portata a casa.
Marco, che il giorno prima aveva già testato la gamba, torna in pista e, insieme a tutti gli altri, si dirige verso la parete sopra il Damm, anch’essa con nome ignoto. La chiameranno Al Wal, interpretazione di un’indicazione fornita da un locale sulla possibile toponomastica del luogo. Qui tracciano Patatonia, una via destinata a diventare una classica.
Io, Matteo e Riccardo ci siamo alternati in apertura per tutta la giornata, i primi tiri ci hanno impegnato notevolmente, arriveremo molto alti ma, per pochissimo, non riusciremo ad uscire dalla via e saremo costretti al bivacco. Poco male, avevamo il necessario e percepivamo che l’indomani ci sarebbe mancato veramente poco e su difficoltà modeste. Così, alle 8 del 1° marzo, concludiamo Drips of Joy nome derivato dalla quantità di tiri esaltanti su muri a gocce.
In parete fino all’ultimo giorno!
 Riccardo e Erika dopo "Feel free to create"Siamo poco oltre la metà spedizione e decidiamo di spostare il campo per iniziare a riavvicinarci alla città, facendo alcune tappe lungo il percorso.
Riccardo e Erika dopo "Feel free to create"Siamo poco oltre la metà spedizione e decidiamo di spostare il campo per iniziare a riavvicinarci alla città, facendo alcune tappe lungo il percorso.
Ci piazziamo giù al Damm, posto abbastanza centrale per gli obiettivi di tutti dell’indomani. Matteo e Riccardo non digeriscono l’idea di ripartire senza aver messo mano sulla montagna simbolo del luogo, Jabel Misht. Così optano per una corsa sul classico French Pillar cercando di scappare dalla calura.
Io, Mauro e Francesco torniamo ad Al Wal per aprire Dattero d’oro. Francesco porterà anche un ottimo contributo allo sviluppo del trekking in Oman, segnando con notevole quantità di ometti una via normale della parete, utilissima per la discesa.
Lorenzo, Marco, Erica e Daniele si dirigono verso la via “Le paradis des granouilles”, sempre al Said Wall ma con differente accesso e definita come una delle più belle della zona, ma forse la cosa più bella è stata scalare senza tutor e sappiamo di una giornata di grande goliardia. Alla sera ci ritroviamo tutti soddisfatti ad Al Hamra, finalmente con la possibilità di fare una doccia dopo giorni a mimetizzarci con le capre locali.
4 marzo: ultimo giorno di vie. Matteo e Lorenzo vogliono tornare sulla loro creazione, Sciugomano, per liberare l’ultimo tiro, Matteo ci riesce e lo valuta 7c+.
Un altro gruppetto vuole andare al Wadi Nakar dove l’avvicinamento è pressoché nullo, ma, a dire di Mauro, la parete è stata scalata pochissimo rispetto alle potenzialità, come praticamente tutto in Oman.
Dopo un po’ di indecisione iniziale Erica, Marco e Daniele si dirigono verso la parete a Sud Ovest del wadi per aprire Vento del deserto, io e Riccardo optiamo per la parete a est e apriamo All you need is a date e Crack Pole, quest’ultima una linea tutta in fessura dove sembra di essere sulle nostre Alpi.
 Said Wall e Alkumeira Wall
Said Wall e Alkumeira Wall Wadi Misfats Falaj
Wadi Misfats Falaj
 Incontri con locali al Jabal Fokha
Incontri con locali al Jabal Fokha
 Tramonti omaniti
Tramonti omaniti
 Un po’ di turismo
Un po’ di turismo
Il giorno seguente avevamo già in programma di fare una giornata tutti insieme in falesia e visitare Gorgette, per poi dirigerci verso Mascate. Non ci è rimasto più un briciolo di pelle sulle mani, per cui l’ultimo giorno associamo un po’ di visita alla città e un paio d’ore di deep water solo. Eravamo però anche tutti attratti dalle notti d’oriente e questo fascino medio orientale, per cui, incuriositi, partiamo per un tour in macchina facendo tappa alla Royal Opera. Come potete immaginare, però, le costruzioni dove gli omaniti danno il meglio sono le moschee: tante, luccicanti e illuminate a giorno. La principale, quella del sultano Quaboos, è qualcosa di veramente incredibile, la più grande al mondo, prima di quella di Abu Dabi. La musalla principale (la stanza della preghiera) ospita 6500 persone, è ricoperta da un tappeto di 4343m2 e illuminata da un lampadario di 14 metri.
Dopo la visita alla moschea ci rechiamo al souk, tipico mercatino, ma a parer mio un po’ troppo commerciale e poco caratteristico. Ultimo step, un po’ di mare ma sempre con la possibilità di mettere le scarpette per chi ancora ne avesse voglia, per cui ci rechiamo al porto dove i pescatori sono ben contenti di accompagnare con le loro barche gli arrampicatori a scalare sulle scogliere. Qui l’Oman ci regala un’ultima sorpresa: l’acqua sotto le scogliere non è molto limpida, ma fra le onde si scorgono comunque tantissime tartarughe marine!
 DWS
DWS
 In barca verso il DWS
In barca verso il DWS
Ricordi e impressioni dei partecipanti
I mondi differenti
 di Francesco Leardi Presidente Caai - Gruppo Orientale
di Francesco Leardi Presidente Caai - Gruppo Orientale
Non parlerò di imprese e tecnicismi, piuttosto narrerò i contrasti che gli eventi propongono e spesso, in questa esperienza del CAI Eagle Team si sono interfacciati tra di loro, talvolta anche sorprendentemente.
Come risaputo, sono sempre stato favorevole ad un’iniziativa del genere e la mia partecipazione, per come l’ho vissuta, è stata rappresentativa di una generazione il cui passato è stato un momento di crescite personali ma anche di forte spinta motivazionale per le generazioni successive. Non per tutti, come si sa, anzi, molte personalità hanno sempre pensato a preservare e personalizzare la loro identità con la paura di essere sminuiti.
Ho sempre creduto nei giovani e questa esperienza mi ha permesso di affrontare una realtà materiale che, nella vita reale, è sfuggente perché propinata da social, per carità divulgativi e attuali, sempre sintonizzati sul gesto ma poco sul senso del prima e del dopo.
Così il primo “mondo differente” mi ha offerto le personalità di questi ragazzi che, al mio essere, apparivano quanto mai misteriose, e credo sia il termine giusto, perché i piani di comprensione iniziali erano lontani e diversi.
Da solitario quale sono, ho guardato con interesse, curiosità e un certo distacco, che non voleva essere un atto di presunzione, bensì un personale accrescimento, anche se potrebbe sembrare un paradosso.
La cosa sorprendente comunque è stata vivere questa situazione in un secondo “mondo differente” che è stata la realtà territoriale dell’Oman dove tutto o nulla è scontato.
Credo che la visione del differente fosse ben presente anche nei ragazzi, e non voglio assolutamente dire che la società omanita sia meglio o peggio, ma semplicemente diversa, anzi alcune peculiarità ci hanno sorpreso e, per così dire, hanno accresciuto il valore dell’elemento umano.
Strade sterrate e polverose ci hanno condotto tra le montagne, immergendoci in mondi surreali rispetto ai quali, almeno io, istintivamente e inizialmente, ho pensato che fossero un mondo a parte. Ma non era così, e la percezione di quanto detto la abbiamo avvertita girando tra le case di queste oasi, dove le persone vivono con assoluta dignità e un credo religioso invidiabile e di tutto rispetto.
Ricordo con piacere i datteri che ci hanno offerto nell’oasi di Al Kumaira, ma soprattutto mi emoziona, al di là del materiale, il gesto, compiuto con estrema delicatezza ma anche risolutezza. Il segnale era: “Ti accolgo e rispetto, ma ricorda che sei nel mio territorio!”.
Così ogni mattina arrivavano all’oasi, dopo 11 km di sterrato assai difficoltoso, dei custodi del territorio, ogni giorno diversi, per irrigare con magistrali opere idrauliche i terrazzamenti.
Un episodio che mi ha stupito è stato quando abbiamo fatto un breve periodo di istruzione per insegnare a piantare manualmente gli “spit roc” radunati intorno ad Erica che magistralmente forava la superficie di un masso. Ebbene, un giovane omanita, sorprendentemente ha sguainato il suo smartphone dalla tunica per fare un video alla nostra compagna di avventura. Il senso non era tanto la ripresa del video, ma la assoluta spontaneità con il quale il ragazzo, di ben altra cultura, ha fatto questa operazione accompagnata da uno sguardo assai sereno e compiacente. Così i “mondi differenti” si sono incontrati.
Ci sono due termini con cui definirei il gruppo dei ragazzi: competitivi, ovviamente non solo tra di loro ma molto con se stessi, e amalgamati, che poi è un termine di derivazione araba che significa impasto. Certo, questa avventura, queste prestazioni sono state un impasto di menti, volontà, entusiasmo, determinazione e capacità.
Non ho mai tenuto diari, ma ho sempre scritto per necessità, cercando di cogliere il momento opportuno. Gli aneddoti da raccontare sarebbero molti ma ritengo che il significato del “gruppo” sia emerso da queste poche righe.
Tutti noi ricorderemo con piacere la disponibilità del popolo omanita che in ogni occasione e senza rendiconto ci ha accolto. Dal nulla più totale, tra queste eterne sterrate polverose, compariva ogni tanto una jeep di omaniti che si fermava per chiedere se avevi necessità di qualche cosa o desideravi un passaggio. Un gesto semplice ma significativo ed emozionante come era il momento del saluto quando si portavano una mano al cuore e poi te la porgevano. Una semplice mano che racchiude enormi significati!
Una valigia piena di esperienze
di Riccardo Volpiano
 Oman 2025, spedizione finale del progetto CAI Eagle Team. Per me è stata la mia prima spedizione extraeuropea e in realtà anche la mia prima spedizione alpinistica. Da subito ero molto motivato, non c'era nulla che mi preoccupasse, probabilmente perché il feeling che avevo con il gruppo era molto buono: con gli altri cinque ragazzi abbiamo avuto modo di conoscerci e fare amicizia durante le settimane di formazione del progetto, mentre i tre tutor del Club alpino accademico li ho conosciuti solo qualche mese prima di partire, ma c'è stata subito una grande intesa.
Oman 2025, spedizione finale del progetto CAI Eagle Team. Per me è stata la mia prima spedizione extraeuropea e in realtà anche la mia prima spedizione alpinistica. Da subito ero molto motivato, non c'era nulla che mi preoccupasse, probabilmente perché il feeling che avevo con il gruppo era molto buono: con gli altri cinque ragazzi abbiamo avuto modo di conoscerci e fare amicizia durante le settimane di formazione del progetto, mentre i tre tutor del Club alpino accademico li ho conosciuti solo qualche mese prima di partire, ma c'è stata subito una grande intesa.
Devo ammettere che la spedizione mi ha sorpreso, nel senso più positivo del termine; la bellezza dei paesaggi, la gentilezza della popolazione locale, la quantità di pareti inesplorate, la qualità della roccia, ma soprattutto la libertà di poterci accampare dove volevamo per poter scalare ed esplorare i posti che ci affascinavano di più.
Ecco, se dovessi riassumere questa avventura con una parola sola, credo che sceglierei libertà.
Siamo partiti con un programma più o meno definito, ma senza vincoli stringenti, avevamo individuato i posti che sembravano più interessanti basandoci sul materiale trovato sulla guida e in rete, qualcuno di noi aveva qualche obiettivo preciso, tuttavia, una volta in Oman abbiamo molto spesso stravolto i piani.
Il fatto che di giorno la temperatura raggiungesse a volte i 32 gradi ci ha fatto subito scartare tutti i progetti sulle pareti sud, altri piccoli inconvenienti ci hanno costretto a modificare gli spostamenti previsti dal piano originale, ma siamo riusciti ad adattarci ed elaborare nuovi programmi in modo talmente veloce e organizzato che, riguardando indietro, sembra quasi che fosse il nostro programma fin da subito. È capitato che ragazzi diversi avessero obiettivi diversi, spesso su pareti diverse, ma con la giusta organizzazione e determinazione siamo sempre riusciti a sfruttare al meglio le tre auto e accontentare tutti, ritrovandoci poi la sera stessa o quella successiva a raccontarci a vicenda le rispettive avventure.
In Oman si può passare dalla strada asfaltata, a quella sterrata liscia, a quella sterrata sconnessa nel giro di pochi metri, per fortuna avevamo a disposizione auto 4x4 (anche se abbiamo tribolato un po' per averle) che ci hanno permesso di visitare molti luoghi che altrimenti sarebbero stati irraggiungibili.
Qualsiasi posto poteva diventare casa: sotto un albero, vicino a un fiume, nel letto di un fiume secco. Cinque tende, boccioni d'acqua, cibo, fornelletti e un'ottima compagnia: non si sentiva la mancanza dei comfort di un albergo. Inoltre la possibilità di incontrare pastori o agricoltori locali non era da sottovalutare; infatti, tutti gli Omaniti che abbiamo incontrato o che ci sono venuti incontro per salutarci, ci hanno sempre offerto del caffè o dei sacchetti di datteri o dei pancake, oltre a darci spesso delle indicazioni utili su dove trovare acqua, roccia e cibo. Sono sempre stati molto educati e cordiali, mai invasivi, sempre ospitali.
Ogni giorno, un'ora prima dell'alba, alle 12:30 e al tramonto in qualsiasi punto dell'Oman ti trovassi, si sentivano le preghiere che venivano recitate ad alta voce nelle varie città, grosse o piccole che fossero.
Ad Al Khumeira, un villaggio isolato a 11 chilometri di sterrato dalla città, dove oramai sono presenti solo più ruderi, si trova una bellissima oasi con una vasca per l'irrigazione che si riempie giornalmente e dove l'unico edificio ancora in piedi e ben tenuto è proprio una piccola moschea.
In mezzo a queste distese di terra arida, pietraie, pareti e letti dei fiumi secchi, sono presenti dei magnifici canyon, chiamati wadi, dove l'acqua riesce a dar vita a delle splendide oasi verdi, sempre ben tenute e coltivate. Le pareti rocciose di questi canyon si sviluppano solitamente per diversi chilometri e, oltre a essere estremamente suggestive, sono state spesso l'obiettivo delle nostre scalate.
Per raggiungere le pareti in generale non esistono sentieri, ma solo la motivazione e l'intuito dell'alpinista che ha individuato una linea di salita che lo ha stregato e vuole a tutti i costi arrivare alla base della parete e poi ridiscendere una volta compiuta la missione, nonostante le pietre mobili, gli arbusti spinosi (molto spinosi!) e le temperature a volte molto elevate.
Sulla scalata ci sarebbe molto da dire, ma forse è sufficiente aggiungere che gli ultimi giorni la pelle delle nostre mani era completamente consumata a causa dell'elevata abrasività della magnifica roccia omanita. Non è sempre stato facile individuare e capire quali fossero i punti con la roccia migliore e abbinare correttamente il colore della roccia alla sua solidità, ma a fine spedizione avevamo imparato. Molto spesso si partiva puntando a una zona della parete che sembrava interessante, poi giunti in prossimità, si deviava per evitarla, dal momento che non era come ce la si aspettava, ma qualche metro a fianco si trovava invece una zona con della pietra inaspettatamente bella e compatta.
È stato molto formativo e piacevole poter scalare e aprire nuove vie con tanti soci diversi, imparando da ognuno qualcosa e, soprattutto, divertendosi sempre a prescindere dal socio; una volta abbiamo anche bivaccato in parete! Certamente alcune salite mi hanno dato più soddisfazione di altre, ma quando si è in questi posti, in queste situazioni, ogni giornata è una vittoria: la difficoltà, la lunghezza, la stanchezza perdono valore e rimane solo la gioia per aver trascorso dei bei momenti, in un posto bellissimo, praticando lo sport che ci piace di più.
Abbiamo avuto la possibilità di visitare anche la capitale Muscat e la sua incredibile moschea, oltre ad abbracciare gli splendidi scogli che spuntano nell'oceano lì vicino, praticando "deep water solo" durante l'ultimo pomeriggio prima di ripartire per l’Italia, diventando l'attrazione nell'attrazione per tutti i turisti che stavano effettuando un giro in barca per ammirare gli scogli.
Torno a casa senza rimpianti, con il bagaglio pieno non solo di vestiti, materiale d'arrampicata e datteri, ma anche di bellissime esperienze formative ed esplorative che a priori non mi sarei aspettato.
Non resta che ringraziare di cuore il CAI e il CAAI per questa opportunità, sperando che si ripresenti in futuro, non solo per me, ma anche per altri giovani alpinisti che decideranno di partecipare alle prossime edizioni del CAI Eagle Team.
La sfida di fare gruppo
di Mauro Florit CAAI – Gruppo Orientale

Che dire di questa esperienza se non che tutte le mie sensazioni sono state confermate?
Quello da sempre sostenuto anche stavolta si è rivelato come verità. No, non ho nessuna dote particolare di premonizione, nessun merito, solo una certezza: Gli alpinisti sono lo specchio della nostra società, ma, nel mondo dell’alpinismo, o più in generale dell’arrampicata, c’è una altissima percentuale di brava gente.
I sei ragazzi che ho avuto la fortuna di conoscere in questa esperienza omanita si sono dimostrati delle bellissime persone… belle persone, ancora prima che fortissimi alpinisti. Che fossero dei fuoriclasse alpinisticamente parlando non vi era nessun dubbio, anche conoscendo il lungo ed impegnativo percorso che li ha portati a questa esperienza. Ma che si dimostrassero anche delle persone grandi, non era per nulla scontato. Il loro percorso, fino al momento in cui siamo saliti sull’aereo per l’Oman era, bene o male, una continua sfida per risultare i migliori; riuscire a cambiare radicalmente registro e diventare un gruppo affiatato, che condivideva i medesimi obiettivi, è stata la sfida più impegnativa. Una sfida che hanno saputo accettare e vincere.
Ringrazio Marco e Francesco che, come tutor, hanno saputo lavorare per la riuscita di questa avventura, ma soprattutto ringrazio Erica, Lorenzo, Marco, Matteo, Daniele e Riccardo per avermi ricordato come ero io quarant’anni fa, quando la passione per questa splendida ed inutile attività mi ha contagiato. Auguro a loro, ma anche a tutti quelli per cui la Montagna è terapeutica e motivante, di vivere intensamente ogni momento che la vita ci regala.
Pareti nuove e nuove amicizie
di Lorenzo Toscani
 Chiudo gli occhi un momento e mi addormento. Mi sembra di sentire l’odore di spezie del mercato di Muscat, il continuo vocio dei venditori che cercano di richiamare la nostra attenzione proponendoci merce completamente assurda e inutile.
Chiudo gli occhi un momento e mi addormento. Mi sembra di sentire l’odore di spezie del mercato di Muscat, il continuo vocio dei venditori che cercano di richiamare la nostra attenzione proponendoci merce completamente assurda e inutile.
Siamo in aereo verso Malpensa, mentre faccio un bilancio di questo viaggio. Le emozioni sono ancora fresche e ci vorrà qualche giorno per metabolizzarle. Il posto, le persone, i miei compagni di viaggio: tutto si è rivelato molto meglio delle aspettative, che già erano alte.
E si sa, gli attriti, la roccia brutta, gli incidenti fanno parte del percorso, non potrebbe essere diverso quando parti per scoprire pareti nuove, amicizie nuove.
Personalmente torno molto arricchito da questo viaggio; abbiamo scalato tutti i giorni disponibili, abbiamo aperto delle vie e ne abbiamo ripetute altre, ci siamo confrontati, abbiamo finito strati e strati di pelle, sfondato le scarpette.
Senza dubbio ci sono stati molti momenti da ricordare, ma uno dei più belli è stato sicuramente concludere l’apertura della via Sciugomano (7c+ max) insieme a Teo e Marco. Il crux della via supera prima un tetto orizzontale, per poi affrontare una placca a tacche e buchi. Una linea davvero particolare, tracciata in un canyon praticamente vergine.
Adesso si torna a casa, con il telefono pieno di foto di pareti inesplorate, pronti a studiare gli obiettivi del prossimo viaggio in questa terra così piena di stranezze. Una terra dove la povertà vive esattamente un passo di fianco alla ricchezza, dove chi non ha niente è pronto a dare tutto a dei passanti qualunque come noi, dove l’acqua è un bene sacro e il caldo una costante. Shukran Oman.
Oman, un bilancio culturale, spirituale e personale
di Daniele Lo Russo
 Un viaggio sicuramente atipico per gli arrampicatori. Difficile riassumere due settimane così intense in poche righe senza cadere nel banale e scontato. Ci sarebbero tanti aneddoti da raccontare, ma sicuramente alcuni più di altri sono rimasti impressi nella mia memoria.
Un viaggio sicuramente atipico per gli arrampicatori. Difficile riassumere due settimane così intense in poche righe senza cadere nel banale e scontato. Ci sarebbero tanti aneddoti da raccontare, ma sicuramente alcuni più di altri sono rimasti impressi nella mia memoria.
Si potrebbe dire di come sono trascorsi rapidi i primi giorni sulle Jabal Fokha, guglie di due/trecento metri ad un paio di ore da Muscat, mentre scoprivamo la tranquillità e la lentezza di un popolo sempre sorridente, intanto che aspettavamo i fuoristrada che avevamo chiesto e che: “…domani saranno pronti”.
Oppure di quando, la prima sera, mentre distavamo e rimontavamo sacconi più pesanti di noi, nel parcheggio di terra battuta dove avevamo montato le tende, siamo stati raggiunti da una decina di ragazzini. Venivano curiosi di conoscere quegli strani turisti, dalla pelle chiara e già un po’ bruciata dal sole. Dal thermos hanno riempito un sufficiente numero di bicchieri di carta con dell’ottimo caffè speziato e, con qualche misera parola di un inglese arrancante, ci hanno fatto intendere che avrebbe fatto piacere loro se lo avessimo accettato. Un paio di foto per immortalare il singolare momento e già si stavano allontanando, lasciandoci alle nostre faccende quasi imbarazzati da tanta gentilezza gratuita in quella calda serata.
Si potrebbe dare spazio all’arrampicata, raccontando di quando al Wadi di Misfah Al Abriyyin Marco Ghisio ed io, uniti dalla passione per la scalata in fessura, abbiamo provato ad aprire una linea che ripercorreva un lungo diedro giallo, con l’idea di passare solo con protezioni tradizionali, senza però farcela. Oppure di quando con Erica abbiamo iniziato ad aprire una via sul grande scudo nero verticale al Jabel Kawr. Anche qui però senza sbucare in vetta: dopo quattro tiri dove abbiamo dato tutto ciò che avevamo, infatti, abbiamo buttato giù le doppie con la consapevolezza di aver poco tempo per la difficoltà della via che volevamo aprire e per le nostre capacità. Oppure ancora di quando, uno degli ultimi giorni, al Wadi Al Nakhr, con Erica e Marco, parto tanto demotivato da non sapere nemmeno se scalare o meno e poi mi ritrovo, incitato dai miei compagni, ad aprire un bellissimo tiro di una via splendida, che mi catapulta il morale alle stelle.
Potrei perdermi in descrizioni dei tramonti che fermavano il tempo e ci lasciavano a bocca aperta a guardare l’orizzonte, oppure nel raccontare quanto siano desolanti le distese desertiche che circondano le montagne, e quanta vita contengano le oasi dove abbiamo avuto la fortuna di piantare la nostra tenda e farci un bagno. Oppure ancora potrei raccontare delle cene improvvisate con ciò che avevamo, delle partite a carte, delle sveglie traumatiche per evitare il caldo, delle serate trascorse a raccontare aneddoti, confidenze, dubbi e perplessità, dei sorrisi, delle poche ore di sonno, o dei datteri mangiati in qualsiasi forma, qualità e quantità. Potrei scrivere tutto questo, ma finirei per confondervi o, peggio ancora, annoiarvi. Sono sicuramente racconti che si prestano meglio ad accompagnare una serata davanti a un fuoco, magari nel prossimo viaggio!
Essendo appena rientrato da questa esperienza, e visto che alla fine dei periodi si tirano le somme, vi parlerò di bilanci. Tuttavia, non il classico bilancio fatto di numeri, gradi e valori! Se c’è una cosa che ho appreso da Ragioneria è che i numeri troppo spesso sono un po’ narcisisti e tendono a catturare tutta l’attenzione, oscurando il resto.
Guardando il rapporto tra risultati e tentativi, nel mio caso, questo viaggio potrebbe sembrare un flop, quando invece non è affatto così. Vorrei porre l’attenzione su tre aspetti molto più ampi: culturale, spirituale e personale. Dal punto di vista culturale, infatti, quest’esperienza mi ha sicuramente permesso di assaporare una realtà drasticamente diversa da tutte quelle che ho avuto modo di conoscere durante i miei precedenti viaggi e da quella di casa. In Oman l’estraneo ero io rispetto agli altri e questa diversità è stata accolta dai locali con curiosità ed ospitalità e non con timore. Il discorso spirituale invece è strettamente legato all’arrampicata: gli episodi che ho raccontato spesso si sono conclusi con delle ritirate, e quindi possono sembrare del “tempo perso”. Invece sono state esperienze dove mi sono spinto al limite. Un limite non facile, non difficile, semplicemente mio, dove ho dato tutto me stesso e che mi ha ricalato a terra svuotato delle energie, ma pieno di vita. Per questo non le vedo come sconfitte ma, al contrario, come alcune tra le giornate più belle, produttive e formative passate in parete, di tutta la mia carriera.
Condividere l’intensità di questi attimi assicurato o assicurando amici che provano come te la stessa forte passione per questa strana “filosofia di vita” che è la scalata, è un regalo davvero speciale. Ed è qui che entriamo nel terzo aspetto, quello personale e relazionale. In generale vivere a stretto contatto, in situazioni non sempre facili da gestire, mi ha dato modo di approfondire il rapporto con i miei compagni, creando un legame più forte e solido, permettendomi di scoprire qualcosa in più di loro ma anche di me. Allo stesso modo mi ha fatto scoprire Francesco, Marco e Mauro, tre persone speciali che hanno dedicato il loro tempo e le loro energie a questo progetto, mettendo noi ragazzi e i nostri sogni come priorità davanti alle loro ambizioni.
In conclusione, rientro da questo viaggio “carico”: carico di nuovi amici, di esperienze, di una maggiore conoscenza di me stesso, di ambizioni, di voglia di mettermi in gioco, di fame di arrampicata e di voglia di ripartire! Non potrei essere più contento! Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno dato realtà a questo progetto. In particolar modo il CAAI e il CAI, i tutor Francesco, Marco e Mauro e i miei compagni Erica, Lorenzo, Marco, Matteo, Riccardo: senza di voi tutto ciò non sarebbe stato possibile. Grazie.
Vento del deserto: diario di un’esplorazione inattesa
di Erica Bonalda
 Dopo due anni ricchi di nuove avventure, esperienze, amicizie, soddisfazioni, delusioni… è arrivato il momento di partire. Di partire per la tanto attesa spedizione. Direzione Oman.
Dopo due anni ricchi di nuove avventure, esperienze, amicizie, soddisfazioni, delusioni… è arrivato il momento di partire. Di partire per la tanto attesa spedizione. Direzione Oman.
Atterrati a Muscat, la capitale, mi è caduto il mondo addosso. Forse perché era tutto diverso da come mi aspettavo, forse perché fino a quando non mi ci sono trovata non ho avuto il tempo di realizzare cosa potesse significare. In questi due anni ero passata da sognare la Patagonia a iniziare ad accettare la sconfitta, il fatto che sarei rimasta a casa; un po’ perché non ci avevo neanche provato, non avevo accettato le regole del progetto, avevo combattuto per i miei ideali di montagna; un po’ forse anche per la paura di dover affrontare la Patagonia con una pressione forte come quella di andarci con l’Eagle Team, che agli occhi del mondo esterno è visto come il gruppo dei quindici alpinisti giovani più forti d’Italia. Il progetto è stato guidato da uno dei più grandi alpinisti italiani, Matteo Della Bordella, e noi siamo stati selezionati per creare un gruppo di elite giovanile dell’alpinismo.
Durante il viaggio di andata in aereo percepivo uno stato d’animo a cui non sono così abituata. Era come se la mia attenzione si fosse focalizzata sulla molteplicità di stimoli esterni che l’ambiente offriva, senza lasciarmi tregua. Le luci dei numerosi microschermi che proiettano tutti un’immagine diversa, i rumori, le voci, il pianto della bimba seduta davanti a noi, gli odori umani che si mischiano ai profumi artificiali… sommata all’impossibilità di muoversi negli spazi stretti dell’aereo. Il mio compagno di viaggio dorme e mi blocca il passaggio per alzarmi a fare due passi.
Una volta atterrati ricordo una sensazione di liberazione misto a stupore: l’aeroporto era vuoto e tutto molto pulito, intorno a me oltre ai miei otto compagni di viaggio c’erano solo uomini, ad eccezione di un gruppo di donne che credo fossero indiane, non locali… e poi il paesaggio arido, distese di roccia rotta, montagne di sassi che sembrano volersi sgretolare da un momento all’altro, luce accecante, foschia che non ti lascia percepire l’orizzonte… e poi caldo, tanto caldo…
Il mio primo pensiero è stato: ma dove ci hanno mandato? È una vacanza o siamo qui per lavorare? Siamo qui per combattere una guerra? Per conquistare un pianeta sconosciuto? Quello che riuscivo a vedere con gli occhi semi chiusi per la troppa luce era un paesaggio che ricorda il fondale di un mare senz’acqua.
Quando, dopo due ore di attesa per le auto, siamo riusciti a lasciare l’aeroporto e abbiamo raggiunto la cittadina dove iniziava la strada sterrata per andare nelle montagne, abbiamo deciso di fermarci e preparare le tende per la notte. Poco dopo l’arrivo del buio e di una temperatura che potrei con un po’ di coraggio definire fresco, abbiamo avuto i primi contatti con la popolazione locale: nella penombra ci si è avvicinato in gruppo composto da una decina di ragazzi giovani e due signori più anziani, tutti vestiti con il classico abito intero omanita e il cappello decorato con motivi geometrici. All’inizio non capivamo bene cosa stesse succedendo. Per un attimo ammetto di aver avuto anche un po’ di paura: poi abbiamo capito che loro erano venuti a salutarci, curiosi di cosa ci facessimo lì e ad offrirci datteri e caffè. Le presentazioni sono state accompagnate da una stretta di mano a tutti i miei compagni di viaggio. A me è toccato uno sguardo dapprima sorpreso, poi rispettoso, seguito da un saluto senza alcun contatto fisico.
Sono partita per l’Oman con l’idea di ripetere vie di arrampicata a più tiri. Nello specifico avevo in testa di voler ripetere una via di Hansjörg Auer sulla parete più imponente dell’Oman, lo Jebel Misht. Una volta arrivati in vista della parete mi sono subito resa conto che il mio progetto non sarebbe stato realizzabile. I mille metri di parete dello Jebel Misht dove corre la via “Fata Morgana” mi si sono presentati davanti come un gigantesco specchio riflettente luce e calore. A mezzogiorno era quasi difficile guardarla, senza occhiali da sole ti si chiudevano gli occhi e dopo poco non vedevi l’ora di risalire a bordo dei fuoristrada con l’aria condizionata. All’improvviso le pareti esposte a nord dello Jebel Kawr, sopra la località di Al Kumeira, che dalle immagini presenti sulla piccola guida di arrampicata che avevamo a disposizione non sembravano interessanti, sono entrate a far parte dei miei piani.
Prima di questo viaggio non mi era mai capitato di aprire una nuova via di arrampicata. Ad essere sincera non pensavo che mi potesse piacere, e forse fino ad ora l’avevo vista come una cosa a cui bisogna dedicare tanto tempo e che, ora come ora, non mi interessava.
E proprio sulle pareti di questo Paese tanto diverso dall’Italia, tanto lontano, su una roccia che viene definita calcare, allo stesso modo delle pareti della a me ben nota Valle del Sarca (Arco di Trento), ma che garantisco da scalare è molto diversa dalla roccia di casa, ho capito di aver voglia di provare. A dire la verità è stata anche una necessità, dato che in Oman l’arrampicata come la conosciamo noi deve ancora svilupparsi, le pareti e le linee più belle sono ancora molte volte da scoprire, da creare, da aprire. Dopo una prima esperienza su qualche tiro facile su roccia mediocre, in cui Riccardo con pazienza mi ha insegnato a usare il trapano, con Daniele abbiamo deciso di cimentarci in qualcosa di più simile a quello che rappresenta per me la scalata. Abbiamo scelto una linea dove la parete è verticale, con pochi punti deboli e abbiamo detto: proviamo qui, la roccia sembra bella, l’esposizione non mancherà, l’ingaggio sarà assicurato, la possibilità di non riuscire a passare di là non così lontana…
Arrivati sotto la parete abbiamo preparato il sacco da recupero con tutto l’occorrente: friends, chiodi, martello, spit, trapano, batterie, tanta acqua, arance, datteri… ero un po’ agitata. Sul primo tiro ho fatto fatica, non perché fosse effettivamente difficile da scalare, ma più per l’ansia che mi creava intraprendere questa nuova esperienza. Per tranquillizzarmi e avare fiducia in me stessa mi ripetevo che questa cosa la avevo già fatta tante volte. Pensavo alle volte in cui mi è capitato di perdermi in parete, di finire fuori via. Tutto inizia a non combaciare più con la relazione della via prescelta, e ci si ritrova quindi a scalare su una linea della parete meno percorsa, dove magari si è i primi a toccare la roccia in quel punto. Questo con tutte le difficoltà del caso: capire dove andare, che linea seguire, che sequenza di appigli e appoggi, verificare la tenuta delle prese, rimuovere i massi instabili, decidere se e dove mettere le protezioni di progressione, capire dove costruire la sosta per poi recuperare il compagno… E più pensavo a queste esperienze, più mi veniva in mente l’agitazione che caratterizza queste situazioni di incertezza.
Poi quando è stato il momento di aprire un tiro un po’ più difficile, tutti questi pensieri hanno lasciato la mia mente, che si è concentrata sul momento, sulle sensazioni, talmente tanto da farmi esaurire le forze e installare la sosta dopo neanche venti metri di arrampicata. Alla fine in una lunga giornata abbiamo aperto quattro tiri. Mi sono resa conto di quanto tempo, quanta concentrazione e quante energie servono per aprire anche solo una lunghezza di corda. Ricordo che, quando siamo scesi ho guardato il mio compagno di cordata, Daniele, e gli ho detto “Ma oggi dove è finito il tempo?”
La sera poi mentre scrivevo il mio diario ho capito la differenza fondamentale tra aprire una via e perdersi in parete. Forse ho anche capito perché quest’esperienza tanto intensa mi ha fatto venire voglia di riprovarci. Quando apri una via hai scelto tu di andare a infilarti in un punto della parete che non ha mai scalato nessuno, e lo hai scelto spinto dalla curiosità e dalla voglia di disegnare la tua strada, di costruire la tua opera con la tua etica e le tue regole, di lasciarci in qualche modo una parte di te; questa volta non ci sei finito per sbaglio o disattenzione. Penso che i ridotti stimoli ambientali esterni in combinazione con l’assenza di un percorso già scritto da seguire mi abbiano permesso di concentrarmi talmente tanto su ciò che stavo vivendo da permettermi di vivere uno stato di totale distacco dal mondo esterno.
E così qualche giorno dopo ci abbiamo provato di nuovo. In accordo con il mio compagno di cordata abbiamo deciso di non concludere la via che avevamo iniziato. Forse si trattava di un progetto troppo ambizioso, non tanto per le nostre capacità alpinistiche, ma più per il tempo che avremmo dovuto dedicarci. Sono felice che sia stata anche una decisione condivisa con il mio compagno di cordata. Personalmente, sono felicissima di aver sbattuto il naso contro qualcosa di difficile per me in quel momento, ma sono anche contenta di aver scelto di esplorare anche altre pareti, altri posti e condividere altre esperienze con i compagni di viaggio. Penso che per me la prima volta in cui mi trovo in un posto nuovo sia importante esplorare e dare sfogo alla mia infinita curiosità. In quel momento non sentivo il bisogno di perdermi su una sola linea di roccia.
Uno degli ultimi giorni abbiamo avuto anche una piccola sorpresa. Quella che definirei una soddisfazione anche agli occhi di chi ha seguito dall’esterno il nostro progetto: abbiamo aperto una via, e questa volta anche concluso. Cordata da tre, con Daniele e Marco C., che finalmente ha potuto tornare a scalare dopo il piccolo incidente di inizio spedizione. È stata la volta di “Vento del deserto”, una breve via aperta nel Wadi Nakhar, molto varia come stili di arrampicata e oserei anche dire molto bella. Consigliamo, in comune accordo, una ripetizione al mattino presto, fino a che la parete rimane all’ombra, a meno che non si voglia sfidare il caldo estremo per rivivere l’esperienza di noi apritori, con l’unico vantaggio di potersi svegliare tardi.
Al rientro in Italia e quindi anche alla conclusione del progetto dell’Eagle Team porto a casa due anni di esperienze intense, crescita alpinistica ma soprattutto personale. Porto nel cuore tanti ricordi e tante persone fantastiche con cui condivido una grande passione comune, ma che ognuno di noi, vive un po’ a modo suo.