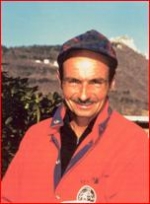CAAI
“Le sport n’est que l’une des époques de la vie d’un grimpeur: la passion de la montagne, elle, est au-dessus du déclin sportif “
L’accademico Georges Livanos in un ricordo di Giovanni Rossi e in una intervista di Paola Favero.
Livanos con Bruno Detassis


Sonia e Georges Livanos

Forse non tutti sanno che il profilo degli strumenti di ancoraggio in fessura conosciuti come friends è quello di una spirale logaritmica.
Il concetto veniva illustrato in modo semplice ed efficace già vent’anni fa da Ledo Stefanini sull’Annuario CAAI nr. 98.
Una interessante lettura per capire lo studio che sta dietro quello straordinario strumento che ci rende oggi piacevole e sicuro scalare fessure un tempo temibili.

“Quello che Casimiro ha fatto in Patagonia può benissimo essere ripetuto altrove, quando un certo ambiente di montagna entra di prepotenza nel cuore e riesce facile spendere tutto per esso”
Renato Frigerio
BIVACCO TEMPORANEAMENTE INAGIBILE - Settembre 2024 ![]() Leggi qui il comunicato
Leggi qui il comunicato
Il Bivacco Ettore Canzio è situato alla quota di 3.818 mt,
all’estremità orientale del Colle delle Grandes Jorasses, tra la Calotte de
Rochefort e la Punta Young delle Grandes Jorasses.
Appartiene al Club Alpino Accademico Italiano e ricorda
Ettore Canzio, fondatore e primo presidente del CAAI. Venne posizionato nel
1961, al posto di un precedente bivacco (Bivacco Città di Monza) installato nel
1950 e misteriosamente precipitato sul versante italiano poco più di un anno
dopo.
E’ un classico bivacco a botte, in legno rivestito di
lamiera, con base di 3 x 3 mt e altezza max di 3,5 mt e può ospitare 8 persone
su tavolato con materassi e coperte.
Altre informazioni sul bivacco e sull'accesso
Un tempo raggiungibile con percorso complesso e non facile
dal Ghiacciaio di Plampincieux per il versante Sud, viene ora raggiunto
esclusivamente dal Rifugio Torino attraverso la Cresta di Rochefort, per
continuare il giorno successivo con la Cresta Ovest delle Grandes Jorasses, che
si attacca giusto dietro il bivacco. La traversata Cresta di Rochefort-Cresta
Ovest della Grandes Jorasses è una delle più classiche ascensioni dell’intero
gruppo del Monte Bianco, straordinariamente panoramica e di moderata difficoltà
su terreno misto, per quanto impegnativa per lunghezza, quota e severità
dell’ambiente.
Il Bivacco, che rappresenta un punto d’appoggio di
particolare utilità e importanza sotto il profilo della sicurezza delle cordate
impegnate nella traversata, è stato oggetto di lavori di manutenzione
straordinaria già nel 2012 e poi nel 2016. Una squadra composta dal socio Carlo
Barbolini, dal socio e guida alpina Beppe Villa coadiuvati da Claudia
Baldini e Carlo Matteucci, ha effettuato in ottobre lavori di consolidamento
della massicciata basale e rifissaggio di parti della copertura in lamiera
zincata. Il bivacco è stato anche verniciato esternamente con prodotto
specifico anticorrosivo bicomponente con catalizzatore. E’ stato scelto il
colore RAL 6037 (verde intenso) che assicura particolare resistenza ai fattori
ambientali e maggiore visibilità al bivacco anche in condizioni meteo avverse.
https://clubalpinoaccademico.it/chi-siamo/modulistica-soci/author/891-caaigenerale?start=240#sigProIdf0c7ef094f
Sabato 19 novembre 2016 Palazzo Ducale a Genova ha ospitato
i lavori del Convegno Nazionale CAAI, organizzato dal Gruppo Occidentale.
Il tema del Convegno
AVVENTURA E ALPINISMO – ESPERIENZE A CONFRONTO
è stato sviluppato da una nutrita schiera di relatori qualificati alpinisti, navigatori/alpinisti, speleologi, ciclisti alla ricerca delle radicicomuni dell’avventura che lega le svariate discipline che mettono l’uomo di fronte alle grandimanifestazioni della natura.
Di seguito l’incipit degli interventi, che potete leggere in un sunto più completo scaricando il PDF allegato.
MOTIVAZIONE AVVENTURA
ANDREA GIORDA
introduce nel vivo dell’argomento del convegno, illustrando i tratti della suaavventura in montagna, iniziata circa 45 anni fa e li confronta con quantoaccade oggi. Quello che allora era scontato (alpinismo=avventura) oggi forse non lo è più tanto…
AVVENTURA COME VIAGGIO ISTINTUALE
ALESSANDRO GOGNA
parla del pericolo che la nostra società moderna distrugga e cancelli l’avventura. Si parla già da qualche anno della sicurezza perseguita, quasi imposta e proposta come necessaria in ogni angolo dalla nostra cultura, fin da bambini, sicurezza che diventa incombente e quasi ossessiva…
UN’IDEA DI AVVENTURA
PATRICK GABARROU
sottolinea come l’avventura sia essenzialmente l’esperienza interiore di essere un po’ lontano da tutto e questa sensazione intima, quasi intimistica, si può vivere anche in esperienze tecnicamente non difficili…
AVVENTURA E SICUREZZA, UNA RELAZIONE PROBLEMATICA
MARCO GERI
Traccia un paragone e cerca le analogie tra l’avventura che si vive in montagna e l’avventura delle grandi traversate oceaniche. Di recente una rivista nautica specializzata ha paragonato una grande regata transoceanica alla conquista dell’Everest…
L’AVVENTURA IN PUNTA DI PEDALI
GRAZIA FRANZONI e MARCO BERTA
Grazia e Marco, affermati ciclisti, si collegano materialmente all’alpinismo introducendo una breve panoramica delle salite ai seimila delle Ande con avvicinamento in bicicletta, un modo per avvicinarsi con
più consapevolezza ed entrare in sintonia con la montagna…
LA SPELEOLOGIA, ULTIMA ESPLORAZIONE
SIMONE BAGLIETTO
Andare in grotta è una disciplina molto complessa e faticosa, ma ti da molto. Andare in grotta è forse una delle più profonde esperienza di avventura che si possano vivere oggi…
GIANNI CALCAGNO – STILE AVVENTURA
MARCO SCHENONE
Marco Schenone ricorda la figura del grande alpinista ligure Gianni Calcagno, rievocando con immagini inedite del Tirich Mir (7.705 mt, in territorio pachistano) che Gianni salì con Machetto nel 1975 per ben due volte nel giro di pochi giorni…
ORIZZONTALE-VERTICALE, LA FORZA DELLA DIFFERENZA
MANRICO DELL’AGNOLA
trae spunto dalla traversata della Groenlandia Est/Ovest effettuata nel 2000 con la moglie Antonella Giacomini, con l’esordiente M. Portrandolfo e Giuliano De Marchi per mettere a confronto l’avventura che si vive nelle grandi scalate e quella che si vive in una grande traversata artica…
L’AVVENTURA COME IMPEGNO SOCIALE – GUIDO ROSSA
SABINA ROSSA
Sabina, figlia del socio accademico Guido Rossa ucciso a
Genova nel 1979, traccia un breve ricordo del padre…
https://clubalpinoaccademico.it/chi-siamo/modulistica-soci/author/891-caaigenerale?start=240#sigProIdad6d42539c
Ignazio Piussi, alpinista dalla forza leggendaria e dal carattere aspro come le sue montagne, viene raccontato in due articoli comparsi sull'Annuario CAAI a firma di Cirillo Floreanini e Alberto Rampini.


Roberto Osio, valente alpinista lombardo, fu Presidente del Gruppo dei Ragni e Presidente del Club Alpino Accademico dal 1978 al 1990.
La creatività è il nostro impegno verso la bellezza, qualcosa che nasce dal profondo e porta un dono al mondo e lo rende più bello.
Ed è proprio la spinta creativa che ognuno di noi deve ricercare in se stesso che ha condotto me ed i miei compagni di cordata a progettare l’apertura
di nuove vie in territorio Corso. Per questo progetto, importante ed ambizioso al tempo stesso, sentivamo il bisogno di individuare delle pareti che
rispondessero a ben precise caratteristiche....
Scarica le relazioni e gli schizzi.



-

-

-

-

-
 Monte Bertonze - Splendidi soli
Monte Bertonze - Splendidi soli
Monte Bertonze - Splendidi soli
Monte Bertonze - Splendidi soli
-

-

-

-

-

-

-

-
 Monte Butara - Orizzonte degli eventi
Monte Butara - Orizzonte degli eventi
Monte Butara - Orizzonte degli eventi
Monte Butara - Orizzonte degli eventi
-

-

-

-
 Monte Cavallare - Duemiladieci e Pietra di nuvola
Monte Cavallare - Duemiladieci e Pietra di nuvola
Monte Cavallare - Duemiladieci e Pietra di nuvola
Monte Cavallare - Duemiladieci e Pietra di nuvola
-

-

-

-

-
 Punta U Finellu - Gocce di tempo.
Punta U Finellu - Gocce di tempo.
Punta U Finellu - Gocce di tempo.
Punta U Finellu - Gocce di tempo.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

https://clubalpinoaccademico.it/chi-siamo/modulistica-soci/author/891-caaigenerale?start=240#sigProId082e73238b
Il racconto della piccola spedizione alpinistica di Giovanni Pagnoncelli e Marcello Sanguineti (CAAI, Gruppo Occidentale) nel massiccio di Ala Archa (catena montuosa di Ala Too, Tien Shan Kirghizo). Il bilancio: tre vie nuove, aperte in stile rigorosamente trad (nessun uso di spit, né con trapano né a mano), due delle quali su vette che erano ancora senza nome.
Vedi al link l'articolo su Planet Mountain, che segue quello già pubblicato sul nostro sito nella sezione "RELAZIONI"
L'assemblea autunnale 2016 del Gruppo Orientale CAAI si terrà il giorno 4 dicembre nella sede CAI di Padova, in Via
Giovanni Gradenigo n° 10.
Allegato l'estratto della lettera di convocazione, che verrà spedita a tutti i soci del Gruppo.
CONVEGNO NAZIONALE CAAI - GENOVA 19/20 NOVEMBRE 2016
L’Alpinismo è da sempre Avventura, ed alcune sue forme lo sono al massimo livello.
Ma cosa significa Avventura nell'era di internet, dei telefoni satellitari, del gps ?
E quali le implicazioni etiche dell'Avventura oggi, cosa è lecito e cosa invece ne travalica l’essenza ?
Un confronto tra gli Accademici allargato ad altre esperienze, per cercare la chiave di lettura di una passione comune.
Cari amici e colleghi
vi confermo che che al convegno di Genova del prossimo
sabato abbiamo il piacere di avere con noi uno degli alpinisti più
rappresentativi della scena mondiale PATRICK GABARROU.
Nonostante i suoi impegni, di guida e conferenziere ha
scelto di venire al nostro convegno come segno di eccellenza.
Mi ha già mandato il suo bel video del Cervino, la sua
ultima impresa, e farà un intervento sull'Avventura appositamente per noi.
Non da meno sono tutti gli altri relatori, il cui elenco è ricco
e vario.
Mi auguro che in molti sarete presenti per questo
appuntamento annuale che negli ultimi anni ha visto un crescendo di interesse
grazie allo sforzo ideativo e organizzativo di tutti i Gruppi lo hanno
organizzato.
Il CAAI vive di partecipazione...a presto